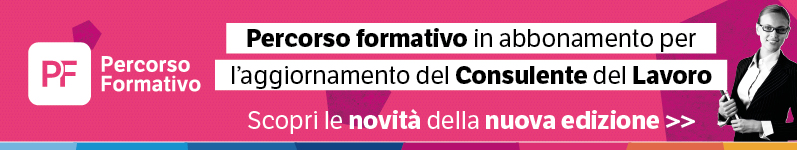Rinunce e transazioni: l’effettiva assistenza al lavoratore da parte dell’organizzazione sindacale
di Alberto Borella
La sentenza del Tribunale di Roma n. 4354/2019 offre un interessante spunto in materia di inoppugnabilità ai sensi dell’articolo 2113 cod. civ. delle rinunce e transazioni sottoscritte per quanto riguarda il requisito dell’assistenza in sede sindacale quale disciplinata dagli articoli 411 e 412-ter c.p.c.. L’analisi della decisione del Tribunale capitolino ci suggerisce alcuni accorgimenti per evitare di vedersi contestata la definitività della rinunce sottoscritte dal lavoratore in tali sedi.
Introduzione
La sentenza del Tribunale di Roma n. 4354/2019 è salita alla ribalta delle cronache per aver richiamato l’attenzione degli operatori del settore su un requisito di validità delle conciliazioni avvenute in sede sindacale affinché si realizzi la definitività delle rinunce che la legge riconosce all’accordo raggiunto tra le parti in causa. Si è, infatti, evidenziata, in quest’ottica, l’imprescindibile regolamentazione della procedura conciliativa da parte del contratto collettivo applicato in azienda.
Ma non è di questo rilievo che ci occuperemo – trattasi peraltro di una sentenza al momento isolata e che è apparsa ai più eccessivamente formalistica – bensì di ben altro aspetto: l’analisi fatta dai giudici capitolini in relazione al principio della “effettiva assistenza sindacale”.
La sentenza del Tribunale di Roma n. 4354/2019
La decisione del Tribunale capitolino, rifacendosi al richiamato principio dell’effettività dell’assistenza prestata dai rappresentanti sindacali – che si sostiene essere “requisito essenziale nella conciliazione in sede sindacale” (seppur non citato negli articoli 411 e 412-ter c.p.c.) – giunge a escludere, nel caso di specie, il realizzarsi dell’inoppugnabilità della conciliazione, prevista dall’articolo 2113 cod. civ., per un’anomalia nelle concrete modalità di svolgimento della procedura, e in particolare la qualità dell’assistenza prestata alla ricorrente dal proprio rappresentante sindacale, che porta a ritenere che non sia stata assicurata un’efficace rappresentazione del contenuto e delle conseguenze derivanti dagli atti compiuti dalla lavoratrice, in modo che possa considerarsi che quest’ultima sia stata davvero libera e consapevole. Questo quanto emerso dall’istruttoria:
“– in assenza di qualsiasi rivendicazione proveniente da parte dei sei lavoratori parasubordinati occupati presso la società resistente da molti anni, fu proprio l’amministratore unico di questa a rappresentare loro l’esistenza di difficoltà nella gestione della casa editrice, l’imminente soppressione dell’istituto della contrattazione a progetto e l’opportunità di ottenere sgravi fiscali attraverso la stipulazione di contratti di lavoro subordinato a seguito dell’entrata in vigore del Jobs Act;
– fu lo stesso datore di lavoro a contattare il sindacalista che nessuno dei lavoratori precedentemente conosceva;
– che solo qualche giorno prima della firma del verbale di conciliazione (avvenuta il 21 aprile 2015) il consulente del lavoro della società aveva predisposto una bozza di conciliazione priva però dei riferimenti all’importo economico oggetto della transazione;
– che il giorno 21 aprile 2015 avvenne la sottoscrizione da parte di ciascuno dei sei lavoratori del verbale di conciliazione, conosciuto solo in quella sede nella sua versione finale (comprensiva cioè dell’importo economico della transazione), alla presenza del lavoratore, dell’amministratore unico della società, del sindacalista e del consulente del lavoro;
– che fu proprio lo stesso giorno, in quella occasione, che ciascun lavoratore firmò la lettera di conferimento del mandato al suddetto sindacalista”.
Tutte queste circostanze hanno convinto il giudice del lavoro, che, pur escludendo qualsiasi coartazione, neppure morale, da parte di chicchessia, operata in danno della ricorrente ai fini di estorcerne la firma, sia venuto a mancare nella vicenda un contegno concretamente protettivo nei confronti della lavoratrice da parte del sindacalista, un comportamento, cioè, idoneo a renderla realmente consapevole della portata dell’atto che si accingeva a sottoscrivere, che in sostanza è quel che la legge richiede per rendere la conciliazione non più oppugnabile.
Il Tribunale romano riporta a sostegno le dichiarazioni del rappresentante sindacale, che riferisce di essersi limitato a compiere le seguenti attività: “Ho fatto sottoscrivere il mandato di rappresentanza alla lavoratrice, dato tempo di leggere il verbale anche sapendo che l’aveva letto prima, come gli altri lavoratori. Ho appurato che vi era volontà conciliativa di entrambe le parti. Non è stata mai detta la frase relativa alla necessità della firma come condizione di proseguire il rapporto. E vero che io non conoscevo la ricorrente, come non conoscevo neppure il datore di lavoro“.
Di fatto, si legge nella sentenza, il sindacalista si era limitato a presenziare, a dare lettura del verbale (o addirittura a dare il tempo di leggerlo ai diretti interessati) e a spiegare che con la firma non sarebbe più stato possibile svolgere successive contestazioni; egli nulla sapeva sulla concreta vicenda della ricorrente, non era informato della sua specifica situazione; non ha illustrato la portata della decisione di aderire alla conciliazione sul piano dei costi/benefici, limitandosi ad affermare l’irrevocabilità della scelta. La sentenza conclude bollando l’attività del rappresentante sindacale quale di mero testimone.
Al contrario, prosegue il giudice capitolino, “in materia di atti abdicativi di diritti del lavoratore subordinato, le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi, contenute in verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale, esigono (e in questa misura diventano inoppugnabili) che sia stata prestata una reale ed effettiva assistenza da parte dei rappresentanti sindacali, della quale non ha valore equipollente quella fornita da un legale e neppure eventualmente da un consulente del lavoro, così da porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinunci e in quale misura, nonché, nel caso di transazione, a condizione che dall’atto stesso si evinca la questione controversa oggetto della lite e le reciproche concessioni in cui si risolve il contratto transattivo ai sensi dell’art. 1965 cod. civ. (Cass. 23 ottobre 2013, n. 24024)”.
In senso analogo si era poco tempo prima espressa, coerentemente con la giurisprudenza costante, l’ordinanza n. 9006/2019 della Corte Suprema di Cassazione, che aveva anche evidenziato la necessità che dalla scrittura contenente la transazione debbano risultare gli elementi essenziali del negozio e, quindi, la comune volontà delle parti di comporre una controversia in atto o prevista, la res dubia, vale a dire la materia oggetto delle contrastanti pretese giuridiche delle parti, nonché il nuovo regolamento di interessi, che, mediante le reciproche concessioni, viene a sostituirsi a quello precedente cui si riconnette la lite o il pericolo di lite.
Le cose da evitare
È palese come nella vicenda qui narrata sia stata commessa da parte datoriale una serie di ingenuità che hanno di fatto reso la vita facile alla lavoratrice ricorrente nel dimostrare i vizi nella formazione della propria volontà abdicativa, in modo libero e consapevole, per colpa del datore di lavoro.
Da questi errori possiamo ricavare un primo elenco delle cose da non fare, ovvero:
- ricorrere a sindacalisti di fiducia o di comodo, soprattutto contattarli direttamente per affidargli o anche solo per prospettare loro la possibilità di un incarico da parte di terzi;
- non discutere di alcunché con i sindacalisti prima che questi abbiano conferito direttamente con i propri assistiti;
- porre a disposizione del rappresentante sindacale dei lavoratori l’eventuale bozza di conciliazione con un largo anticipo rispetto alla data della conciliazione e, ove possibile, contenente una prima proposta economica. Questo al fine di permettere al sindacalista di sottoporla e di discuterne con il lavoratore e, magari, avanzare una controproposta;
- esigere la visione della lettera di conferimento del mandato al sindacalista firmata dal lavoratore. Sarebbe bene che il mandato avesse una data antecedente alla formulazione della proposta transattiva presentata dall’azienda al sindacalista.
Chi scrive ritiene, invece, non determinante il fatto, rilevato nella causa qui in analisi, dell’assenza di qualsiasi spontanea rivendicazione proveniente dal lavoratore. Nulla vieta di prevenire una lite, che il datore di lavoro teme possa insorgere, prospettando alle potenziali controparti la disponibilità a trattare a determinate condizioni in relazione all’alea futura di possibili rivendicazioni. L’importante è che il lavoratore proceda poi con le proprie gambe – eventualmente aiutato e assistito da un sindacalista di sua scelta – nel processo decisionale transattivo, valutando liberamente ciò che ritiene congruo come giusta contropartita per la rinuncia che gli è stata richiesta.
Alcuni accorgimenti pratici
Oltre che prestare la massima attenzione alle cose da evitare, sarebbe opportuno dare formalmente conto di come la fase preliminare e propedeutica alla conciliazione si sia svolta tra le parti.
Il consiglio che chi scrive si sente di offrire è quello di fare risultare tutto ciò nelle premesse del verbale di conciliazione, con una formula che potrebbe suonare pressappoco così:
“PREMESSO CHE
- a) il lavoratore ha provveduto in totale autonomia alla scelta del proprio rappresentante sindacale, conferendo in data _________________ al predetto sindacalista mandato a tutelarlo e rappresentarlo nella presente vertenza;
- b) che in funzione del mandato ricevuto il sindacalista ha preso contatti con la datrice di lavoro al fine di verificare la possibilità di addivenire ad una soluzione bonaria delle vertenza;
- c) il lavoratore ha preso visione in data _________________ per il tramite del proprio rappresentante sindacale della bozza del presente verbale di conciliazione contenente le proposte aziendali;
- d) che ha avuto modo di leggerlo con attenzione, discutendone il contenuto con il proprio rappresentante sindacale, comprendendo quindi il senso e gli effetti;
- e) il lavoratore ha valutato e concordato con il proprio rappresentante sindacale le possibili modifiche alla bozza datoriale e queste, nei termini accettati dalla controparte, risultano oggi inserite nel verbale di conciliazione che le parti intendono sottoscrivere;
- f) il lavoratore ha pienamente compreso, grazie alla reale ed effettiva assistenza del proprio rappresentante sindacale, la portata e la misura dei diritti a cui si accinge a rinunciare, e l’entità delle reciproche concessioni in cui si risolve il contratto transattivo;
- g) che il rappresentante sindacale ha confermato tutte le dichiarazioni del lavoratore in merito ai punti a), b) c) d) e) ed f); (…)”.
Si tenga presente che nelle aule giudiziarie vi è un’innegabile tendenza a considerare parte debole il lavoratore e, quindi, ricordando il principio “melius abundare quam deficere”, è utile citare nel verbale tutto ciò che potrebbe dimostrare, un domani, che il lavoratore è stato messo nella migliore condizione possibile di sapere a quale diritto stava rinunciando e in quale misura.
Osservazioni critiche
Diciamocelo con estrema franchezza: la sentenza è pienamente condivisibile nella sua sostanza. Qui la volontà dei lavoratori – seppur circostanza malamente evidenziata in sentenza – è stata in modo palese indirizzata dal datore di lavoro, il quale ha messo i lavoratori di fronte a un fatto compiuto.
La questione è diversa, e come tale non condivisibile, ove si intenda far passare il concetto, il principio di diritto, che nelle conciliazioni sindacali, in cui il rappresentante del lavoratore non svolge appieno il suo compito, non si realizza l’inoppugnabilità delle rinunce e delle transazioni sottoscritte.
Ipotizziamo che per mille motivi il lavoratore non sfrutti appieno la consulenza del sindacalista da lui scelto in piena autonomia. Si pensi alla supponenza e alla boria di un lavoratore che crede di sapere tutto o che ha il famoso “cugino” che ha già fatto una conciliazione e gli ha spiegato ogni cosa.
Che deve fare un datore di lavoro? Il terzo grado al lavoratore e al sindacalista per capire cosa è stato spiegato da quest’ultimo e cos’ha effettivamente compreso il primo? E se anche si evidenziasse che qualcosa non è stato fatto come si deve, dovrebbe rinviare la firma della conciliazione, invitando lavoratore e sindacalista agli opportuni approfondimenti? E se il sindacalista insistesse che lui le cose le ha fatte per bene, dovrebbe invitare o obbligare il lavoratore a sceglierne un altro?
Non scherziamo, che poi i motivi di illegittimità sarebbero altri.
Ma si pensi anche alla possibilità che il lavoratore ricorrente sia l’impiegato dello studio professionale di un consulente del lavoro che gestiva proprio le pratiche di conciliazione. Pensiamo veramente che l’assistenza di un rappresentante sindacale rappresenti, sempre e in ogni caso, quel quid indispensabile per garantire la legittimità dell’atto transattivo?
Su questo punto sarebbe opportuno che i giudici prestassero particolare attenzione a non fare, come si suol dire, di tutta l’erba un fascio. In tal senso appare censurabile, in quanto non adeguatamente contestualizzata, la motivazione che il Tribunale romano esprime al termine dei propri ragionamenti: “Insomma tirando le fila di quanto fin qui argomentato, la conciliazione è impugnabile e l’impugnazione è tempestiva e fondata in quanto la lavoratrice non ha ricevuto una reale assistenza e non è stata messa in grado di scegliere in modo consapevole”.
Lo ripetiamo: sbaglieremmo ove volessimo interpretare questa affermazione come un principio di ordine generale. Perché va bene rimediare a un errore, ma non tener conto della correttezza e buona fede della parte avversa appare frutto di un’ideologia stantia, che vede nel datore di lavoro il Pantalone che paga sempre e comunque per gli errori e la superficialità dei propri lavoratori o, addirittura, di coloro che essi stessi hanno individuato per la tutela dei propri diritti.
Considerazioni finali de iure condito e de iure condendo
Vi è anche un aspetto che – e chi scrive lo dice sommessamente, ma anche sperando che ciò possa essere uno spunto per una modifica o precisazione normativa – andrebbe considerato ed è l’affermazione citata nella decisione qui in commento del Tribunale di Roma: “le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi, contenute in verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale, esigono (e in questa misura diventano inoppugnabili) che sia stata prestata una reale ed effettiva assistenza da parte dei rappresentanti sindacali, della quale non ha valore equipollente quella fornita da un legale e neppure eventualmente da un consulente del lavoro …”.
Partiamo da ciò che si considera o deve essere ritenuta “sede sindacale”. Si è detto che questa non debba individuarsi tanto in una sede fisica, ma in quella in cui il sindacalista intervenuto offre al lavoratore un contributo non meramente formale, ma sostanziale, nella formazione della volontà transattiva. Una lettura che, in tutta onestà, chi scrive ritiene giuridicamente poco convincente.
Proviamo a ragionare insieme partendo dall’articolo 412-ter c.p.c., che così dispone: “La conciliazione e l’arbitrato, nelle materie di cui all’articolo 409, possono essere svolti altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative”.
Nessun dubbio che per legge i contratti collettivi possano individuare il luogo della conciliazione, individuandolo presso la sede di una delle 2 organizzazioni sindacali firmatarie. Ma anche no.
Nessun dubbio che i contratti collettivi possano individuare, e parrebbe anche entro ampi margini di autonomia e discrezionalità, regole e procedure che consentano, quantomeno secondo le intenzioni dei firmatari, alla conciliazione così raggiunta la piena tutela dei diritti del lavoratore.
E ci sentiamo pure di affermare che il conciliatore potrebbe essere legittimamente individuato dal contratto collettivo in uno o più soggetti facenti parte di una o di entrambe le organizzazioni firmatarie l’accordo. Oggi, forse proprio a causa della mancanza di discipline contrattuali specifiche, si registrano soluzioni e procedure conciliative tra loro molto diverse. Di norma, il collegio di conciliazione è formato dai rispettivi rappresentanti sindacali, del lavoratore o del datore di lavoro. Altre volte – come nel caso discusso dal Tribunale di Roma – troviamo il rappresentante sindacale della lavoratrice che funge da conciliatore di parte in contrapposizione al conciliatore liberamente scelto dalla parte datoriale. Altre volte, ancora, viene nominato un conciliatore di estrazione sindacale, che funge quindi da terzo, lasciando alle parti, lavoratore compreso, la scelta di farsi rappresentare da chi crede: un rappresentante sindacale, ma anche un legale di fiducia.
Tutto ciò porta a una dirimente considerazione. Se da un lato è vero che i pochi Ccnl che disciplinano la conciliazione in sede sindacale prevedono la modalità collegiale con la presenza dei rispettivi rappresentanti sindacali, è altrettanto vero che le altre modalità conciliative sopra descritte sono oggi pacificamente utilizzate dagli stessi sindacati. Questo porta a ritenere che un accordo collettivo potrebbe prevedere e disciplinare, senza remora alcuna, le predette tipologie, dato che già le OO.SS. operano nella convinzione che queste realizzino gli effetti definitivi di cui all’articolo 2113 cod. civ..
In questo quadro, si può ritenere che l’espressione “tentativo di conciliazione in sede sindacale” sia da riferire, piuttosto che a sedi fisiche, alla procedura approvata in un “contesto sindacale”, nel quale la presenza di conciliatori e/o rappresentanti delle parti riconducibili esclusivamente alle rispettive organizzazioni sindacali non è richiesta dalla norma e, pertanto, non può essere ritenuta presupposto essenziale. L’importante è che la regolamentazione della procedura sia stata concordata e disciplinata a livello contrattuale (sindacale appunto), perché è ciò che offre la garanzia della tutela degli interessi delle 2 parti, non solo del lavoratore.
Ipotizzando, quindi, che in un futuro potremmo vedere regolamentate dagli accordi collettivi tutte e 3 le tipologie conciliative sopra individuate, ci dobbiamo chiedere se l’obbligo di un’effettiva assistenza sindacale verrebbe imposta dai giudici anche per la conciliazione “monocratica”, dove il lavoratore è assistito liberamente da un legale. Se così fosse, a chi competerebbe questo compito? Se, come sostiene il Tribunale di Roma, quella fornita dal legale non può essere ritenuta idonea, se ne dovrebbe occupare anche il terzo conciliatore? E perché mai? Perché di estrazione sindacale?
In sostanza il conciliatore – oltre ad accertare la volontà delle parti sottoscriventi, la disponibilità dei diritti transati e il grado di consapevolezza di ciascuna di esse in ordine alla loro abdicazione – dovrebbe pure entrare nel merito del tipo di percorso decisionale fatto dal lavoratore, indagando e sindacando, quindi, la quantità e qualità dell’operato dell’avvocato del lavoratore. Una pretesa chiaramente eccessiva, dato che non risulta che questo tipo di accertamento sia richiesto, ad esempio, ai componenti la Commissione istituita presso l’ITL. Anzi, spesso è proprio la presenza in tale sede del legale del lavoratore ad essere considerata quale garanzia di totale consapevolezza transattiva.
Se, quindi, avvocati e anche consulenti del lavoro sono pacificamente ammessi ad assistere i propri clienti nelle conciliazioni svolte in ITL, per quale motivo i giudici dovrebbero ritenere che l’assistenza fornita dagli stessi professionisti a favore del lavoratore non abbia, in sede sindacale, valore equipollente a quella svolta da un sindacalista?
Personalmente, trovo offensivo che un consulente del lavoro – a cui un lavoratore si è rivolto per libera scelta e in totale fiducia – venga considerato inattendibile per il mero fatto che “di norma” costui è una figura che assiste le aziende. Inaccettabile la sottintesa presunzione che un consulente del lavoro o un avvocato abbiano una sorta di cordone ombelicale con il mondo aziendale per cui, in sede conciliativa, farebbero l’interesse datoriale per vocazione in danno del proprio cliente, seppur pagante le loro parcelle.
Se l’effettiva assistenza, come sottolineato dalla sentenza capitolina e confermato da costante giurisprudenza, rappresenta un problema “sostanziale” e non formale; se, altresì, si ritiene insufficiente che l’assistenza venga fornita da un soggetto qualificato sindacalista, perché di costui deve in primis essere valutata l’idoneità del comportamento a fornire al lavoratore la piena consapevolezza delle rinunce e delle transazioni sottoscritte, dove “sostanzialmente” risulterebbe carente l’assistenza fornita da un avvocato giuslavorista piuttosto che da un consulente del lavoro?
Chi e cosa si vuole tutelare con tali decisioni? I diritti del lavoratore o le prerogative del sindacato?
Si segnala che l’articolo è tratto da “La circolare di lavoro e previdenza“.
Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia: