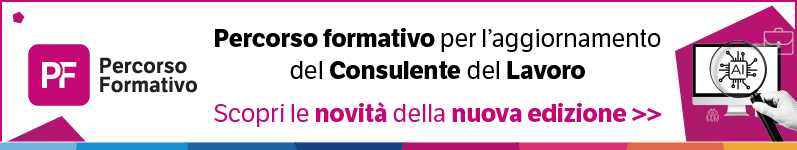Riduzione di personale nella crisi d’impresa: i licenziamenti individuali
di Riccardo Girotto
L’aspetto gestionale degli esuberi nel nuovo Codice della crisi d’impresa viene rivisto tramite il riordino delle diverse tipologie di recesso in area economica.
I licenziamenti individuali rappresentano un fenomeno di per sé minoritario in ambito concorsuale, in quanto le aziende in stato di decozione in linea generale mirano a disfarsi dell’intera forza lavoro, o gran parte di questa. Rileva, però, come la trattazione dei licenziamenti individuali sia necessaria tanto per regolare i recessi plurimi nelle aziende che non integrano il requisito occupazionale utile al coinvolgimento nelle procedure collettive, quanto per affrontare il caso di licenziamenti operati per espressa scelta strategica del curatore, indipendentemente dalla cessazione o meno dell’attività.
Con il presente contributo si proverà inoltre ad approfondire, cavalcando l’apprezzabile intento del Codice della crisi d’impresa, l’aspetto legato a tempi ed effetti delle azioni di licenziamento individuale, allo scopo di offrire strumenti sempre più puntuali, nonché a ridurre il margine d’azione dell’alea a carico degli organi della procedura.
Come cambia la motivazione
La questione della motivazione nell’istituto del licenziamento ha vissuto una storia alquanto articolata: fino all’entrata in vigore della L. 92/2012, infatti, in vigenza dello Statuto dei Lavoratori, l’intimazione del recesso non imponeva l’indicazione specifica dei motivi, salvo richiesta da parte del lavoratore da riscontrare obbligatoriamente. In assenza di espressa richiesta il licenziamento esprimeva, comunque, i propri effetti, agevolando così la posizione del recedente e imponendo l’impugnazione “al buio”. Chiaramente, l’onere della prova doveva comunque risultare assolto nel corso dell’eventuale successiva vertenza, permettendo, però, di fruire del tempo necessario all’ideazione di un percorso difensivo efficace.
La L. 92/2012 impone, quindi, la motivazione immediata, conferendo all’assenza della stessa conseguenze pregnanti tali da spingersi anche, tramite evoluzioni interpretative, fino alla “manifesta insussistenza” del motivo scatenante recesso; convogliando tale aspetto nel tema dei licenziamenti nelle procedure concorsuali, si assume come anche il curatore risulti chiaramente investito dall’obbligo motivazionale, complicandone quindi il ruolo alla luce dei possibili scenari risarcitori.
Vieppiù l’articolo 2119, cod. civ., nella stesura precedente al Codice della crisi d’impresa, riportava chiaramente all’ultimo comma “Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto il fallimento dell’imprenditore…”: detta previsione di chiusura, sorta in un’epoca precedente rispetto al consolidamento del principio esclusivo dalla giusta causa rispetto a tutti i licenziamenti estranei all’ottica disciplinare, non infieriva certo in modo totale nell’azione delle ipotesi risolutive in caso di insolvenza, in quanto doveva interpretarsi come riconducibilità tipizzata dei licenziamenti nel fallimento ai recessi di area “certamente” economica. In linea di principio, quindi, i recessi nell’azienda decotta rappresentavano sempre una soluzione oggettiva, mai potevano, invece, integrare una giusta causa con quanto ne conseguiva in termini di preavviso, possibile risarcimento ed effetti temporali.
Il nuovo Codice, all’articolo 189, ritiene invece necessario modificare l’aspetto causale del recesso, innanzitutto con l’incipit assoluto “L’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del datore di lavoro non costituisce motivo di licenziamento…” e sottraendo contestualmente[1] la materia all’articolo 2119, cod. civ., con la lapidaria chiosa aggiunta “Gli effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti di lavoro sono regolati dal codice della crisi e dell’insolvenza…”.
La nuova dizione elimina ogni riconducibilità allo stato di decozione al fine di validare l’atto di recesso.
Non sarà, quindi, più possibile, nemmeno indirettamente, collegare la scelta del curatore alla dichiarazione di liquidazione giudiziale, obbligando quindi ad approfondire nel testo del licenziamento i motivi che causano l’impossibilità di procedere con lo specifico rapporto di lavoro.
Chiaramente, dovranno formalizzarsi circostanze concretamente dimostrabili, posto che ogni licenziamento risulta liberamente impugnabile e il curatore usualmente non è nella condizione di disporre di somme utili a compensare una rinuncia. Via libera, quindi, ad approfondimenti sui motivi che hanno generato cessazione, anche parziale, dell’attività, a patto che questa sia effettiva, come pure a motivi che hanno escluso un determinato dipendente dal trasferimento d’azienda; al centro dell’atto di recesso dovrà quindi esprimersi un nesso causale completo.
La mancata esplicazione dettagliata del motivo che regge il recesso potrebbe integrare un apparato sanzionatorio gravoso, tanto più qualora il licenziamento riconducesse a un motivo di per sé considerato nullo dalla disposizione civilistica. L’enorme responsabilità che la novella codicistica carica sul curatore andrà inevitabilmente confrontata con la nuova ipotesi della risoluzione di fatto, che per contro tende, invece, a stimolare l’inerzia dello stesso soggetto, che in questa seconda ipotesi risulterà quantomeno caratterizzato da rischi risarcitori notevolmente contenuti.
Lo sforzo richiesto dal nuovo articolo 189, Codice della crisi d’impresa, in combinato con l’articolo 2119, cod. civ., verso l’approfondimento della motivazione risulta, pertanto, significativo.
Risoluzione di fatto come ipotesi alternativa
I primi 2 commi dell’articolo 189, CCI, dispongono che, all’apertura della procedura, i rapporti si sospendono di default, obbligando il curatore a dichiarare espressamente l’eventuale interesse al subentro, per il tramite di precipua comunicazione trasmessa ai lavoratori. La mancata dichiarazione porta a una concatenazione preordinata di effetti che si sviluppano fino a determinare, combinati all’inerzia della curatela, il neonato istituto della risoluzione di fatto.
Non è intenzione di chi scrive approfondire nel dettaglio il tema della risoluzione di fatto come regolata nell’articolo 189, CCI, oggetto di specifico contributo a cui si rimanda, ma la stessa ipotesi di recesso dal rapporto deve necessariamente prendersi in considerazione a completamento del tema qui trattato, quale possibile alternativa al recesso individuale.
Esistono, infatti, dei fattori che potrebbero, da una prima lettura, incentivare l’inerzia del curatore, che, vessato dall’obbligo di puntuale motivazione, per quanto temerario, potrebbe non volersi cimentare nell’ipotesi di recesso. La risoluzione di fatto ha l’ambizione di produrre un effetto rescissorio definitivo, ma non sarebbe così sorprendente se la magistratura decidesse di contestare la privazione di valutazione meritocratica del recesso; il curatore, a fronte di una possibile impugnazione, potrebbe quindi rifugiarsi in un porto sicuro.
Eppure il rischio di percorrere questa scelta non è così sottile, considerato come l’articolo 189, comma 4, CCI, abbia assegnato un risarcimento specifico ai casi di recesso di fatto, misurato in un range da 2 a 8 mensilità massime, con un sistema di calcolo caro alle tutele crescenti.
L’aspetto critico non si esaurisce con il calcolo dell’indennità, in quanto il testo di legge dispone che la stessa debba pagarsi in prededuzione. Proprio tale indicazione espone il curatore inerte a un rischio notevole, in quanto la generazione di spese prededucibili, evitabili in caso di licenziamento, danneggerebbe i creditori, che, legittimamente, chiederebbero lumi al curatore circa la scelta operata. Quest’ultimo aspetto di sottrazione di risorse alla procedura potrebbe costringere alcuni curatori, posto che la sospensione del rapporto potrebbe addirittura non risultare governabile qualora richiesta da ITL o singoli lavoratori, ad accelerare i licenziamenti piuttosto che avvicinarsi a una risoluzione, magari evitabile, che andrebbe a pesare notevolmente sui conti della procedura.
In ogni caso le risoluzioni, di fatto o per licenziamento, retrocederanno i propri effetti alla data di apertura della liquidazione giudiziale. Superfluo sottolineare come la variabile legata alla decorrenza della NASpI pesi in modo significativo sulle operazioni di recesso, assunto che l’Inps dovrà adeguarsi nel retrodatare gli effetti della prestazione al fine di non generare effetti di scopertura contributiva e prestazionale.
Problema che pare al momento irrisolto, invece, investe la cessione dell’azienda in seguito alla sospensione, ipotesi peraltro rappresentante il chiaro obiettivo di gran parte degli organi della procedura. Tra l’inizio di una sospensione connessa alla dichiarazione di liquidazione giudiziale e la ripresa dell’attività connessa alla cessione dell’azienda, si realizzerebbe, infatti, un periodo di purgatorio contributivo che rischia di privare definitivamente il lavoratore di una garanzia previdenziale, che, considerato il limite estendibile fino a 12 mesi, non gioverà certamente al lavoratore interessato.
Da qui la scelta del lavoratore risulterà delicata ma determinante: dimissioni per giusta causa e NASpI utile a coprire il periodo dal punto di vista previdenziale, oppure attesa dell’operazione societaria con possibile conservazione del posto e irrecuperabile scopertura contributiva.
Le procedure obbligatorie e il ritorno all’alea
È sempre la L. 92/2012 la protagonista della procedimentalizzazione dei licenziamenti individuali; dall’entrata in vigore della stessa, infatti, le aziende integranti il requisito occupazionale oltre i 15 dipendenti sono obbligate ad avviare specifiche procedure non solo per i licenziamenti individuali in area disciplinare (articolo 7, L. 300/1970), quanto per quelli in area economica (articolo 7, L. 604/1966), rimanendo esclusi solamente quelli irrogati ex D.Lgs 23/2015, pur orfani del meccanismo a tutele crescenti dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 194/2018.
Su tale aspetto tuona il silenzio del Codice della crisi d’impresa, che, pur disegnando una nuova sintetica procedura per i licenziamenti collettivi, non concede il medesimo trattamento snellente agli individuali. Il curatore dovrà, quindi, scandire con la massima attenzione i tempi di intervento delle operazioni di recesso, al fine di non inciampare nell’errore procedurale che, anche in presenza di granitica motivazione giustificatrice, convoglierebbe l’ammissione al passivo di indennità individuata all’articolo 18, comma 2, L. 300/1970, da misurarsi in una forchetta tra 6 e 12 mensilità. Un autogol sicuramente pesante, che si cercherà di evitare.
L’azienda con meno di 15 dipendenti potrà, quindi, cessare il rapporto seduta stante, tramite comunicazione di licenziamento con effetto immediato, avendo cura di motivare il recesso compiutamente, vista l’impossibilità di ricevere la prestazione nel periodo di preavviso in assenza di attività. Chiaramente il lavoratore conserverà il diritto al preavviso che formerà quindi un credito da insinuarsi al passivo.
Diversamente, in caso di occupazione post dichiarazione di liquidazione giudiziale, anche minima, del lavoratore, sarà necessario procedere al licenziamento considerando dovuto in prededuzione anche il periodo di preavviso, tanto lavorato quanto alternativamente liquidato in via indennitaria. Non potrà, infatti, appellarsi all’assenza di prosecuzione dell’attività il curatore che avrà volutamente impiegato il lavoratore.
Venendo, invece, alla rappresentazione occupazionale oltre i 15 dipendenti, rileva come per un licenziamento individuale debba necessariamente avviarsi la procedura ex articolo 7, L. 604/1966, come modificata dall’articolo 1, comma 39, L. 92/2012 (purché, ovviamente, il lavoratore sia stato assunto prima del 7 aprile 2015).
Non si rinviene, infatti, nessuna esimente per i casi di liquidazione giudiziale (prima fallimento) nella norma regolatrice, né il Codice della crisi d’impresa ha ritenuto utile alleggerirne espressamente il percorso.
Sarà il curatore, quindi, ad avviare la procedura tramite comunicazione all’ITL, trasmessa per conoscenza al lavoratore, dichiarando l’intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo e indicando i motivi del licenziamento medesimo, nonché le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato. L’ITL trasmetterà la convocazione presso la propria sede di conciliazione, al datore di lavoro e al lavoratore nel termine perentorio di 7 giorni dalla ricezione della richiesta, al fine di esperire il tentativo di composizione preventiva del licenziamento.
In caso di fallimento del tentativo di conciliazione e, comunque, decorso il termine di conciliazione, il datore di lavoro potrà comunicare il licenziamento al lavoratore. Esiste, altresì, l’ipotesi che la conciliazione si concluda con la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, in realtà poco probabile nel caso di liquidazione giudiziale, per almeno 2 motivi diametralmente opposti: per il curatore, infatti, è assai improbabile poter disporre di somme utili ad agevolare la risoluzione consensuale; per il lavoratore, invece, la prestazione del consenso annullerebbe il diritto all’indennità sostitutiva del preavviso. Rileva comunque la questione NASpI: infatti, tale tutela risulta garantita al lavoratore receduto pur per effetto di una risoluzione consensuale, in quanto confortata dalla sede istituzionale e dalla presenza di un funzionario ispettivo.
In ogni caso, tanto il licenziamento quanto la risoluzione vedono retrodatati i propri effetti alla data di avvio della procedura ai sensi dell’articolo 1, comma 41, L. 92/2012, che non necessariamente coincide con la dichiarazione di liquidazione giudiziale, tanto da assoggettare i dipendenti a un, pur minimo, periodo di sospensione utile al curatore per avviare la procedura. Eppure l’articolo 189, comma 2, CCI, in modo totalmente scoordinato, dispone, diversamente, la retrocessione degli effetti al momento di apertura della liquidazione giudiziale. Sembrerebbe possibile considerare speciale e prevalente quest’ultima disposizione, ovviamente nella speranza che l’istituto si adegui, soprattutto ai fini della procedura utile alla prestazione NASpI.
Il curatore dovrà, quindi, attenersi a obblighi tipici dell’imprenditore in bonis e sicuramente pericolosi per un soggetto che non conosce bene l’azienda, quali ad esempio: l’indicazione precisa dei motivi, l’individuazione delle possibili misure di assistenza alla ricollocazione, etc..
Il primo passo successivo alla nomina a curatore della liquidazione giudiziale non può che essere, quindi, l’individuazione del requisito occupazionale, non tanto e non solo per adempiere all’obbligo amministrativo introdotto dall’articolo 189, comma 2, del Codice della crisi, bensì per individuare la corretta procedura da adottare per irrogare i recessi.
Una volta individuata la corretta procedura, risulterà necessario l’immediato avvio della stessa, pena la generazione, nel corso del ritardo, del periodo sospensivo individuato dall’articolo 189, comma 1, CCI, privando la maturazione del diritto retributivo e contributivo a favore dei lavoratori. Il periodo di sospensione potrebbe tornare utile proprio per identificare il requisito occupazionale, che, nelle aziende decotte, a causa di carenza di documentazione o mancato preciso aggiornamento della stessa, potrebbe non presentare un quadro chiaro nell’immediato.
Incertezza sul periodo di osservazione e sul metodo di calcolo
Assunto che la misurazione occupazionale risulta essere l’adempimento cardine che segna la gestione del personale successivamente alla dichiarazione di liquidazione giudiziale, rileva come detto passaggio abbini, al proprio peso strategico, pregnante valenza amministrativa.
Rileva, infatti, l’obbligo per il curatore di comunicare all’ITL territorialmente competente l’elenco dei dipendenti in forza al momento dell’apertura della liquidazione giudiziale. Il termine per l’adempimento di quanto previsto dall’articolo 189, comma 2, CCI, si attesta in 30 giorni; il giudice delegato, dal canto suo, su istanza del curatore, potrà concedere ulteriori 30 giorni qualora il requisito occupazionale si attesti oltre i 50 dipendenti.
A tal proposito, si consideri come i primi 30 giorni risulteranno determinanti per il computo, in quanto l’estensione, a opera del giudice delegato, risulterà possibile quando l’azienda avrà comunque individuato almeno un requisito specifico, quello cioè del superamento della soglia dei 50 dipendenti. Alquanto contraddittorio pare tale assunto, posto che per la richiesta di proroga si dovrà aver già chiaro il requisito numerico per lo meno per la definizione dei più o meno 50.
Scontata, visto il nostro diritto positivo, l’assenza di metodo univoco e trasversale di computo, non vi è traccia di indicazioni precise nemmeno nella norma qui commentata, posto che la dizione si limita a riportare “più di cinquanta dipendenti”. Pare, quindi, corretto potersi acquisire a questi fini il mero dato statico.
Il numero dei dipendenti investe, altresì, l’interesse dell’ITL, ente al quale il CCI conferisce potere crescente relativamente alla gestione della crisi. Rileva, infatti, come il ruolo dell’Ispettorato risulti primario sia per la trattativa inerente i licenziamenti collettivi, sia per l’informativa da riceversi per il requisito occupazionale, appunto, sia, infine, per la richiesta di proroga della sospensione del rapporto. Non può negarsi certamente un’immediata necessità di formazione dei soggetti preposti, in quanto fino a oggi tale ente non svolgeva alcun ruolo con riferimento alle crisi d’impresa, per la composizione delle quali veniva investito l’organo provinciale del lavoro di area amministrativa e non ispettiva, prevalentemente di localizzazione provinciale.
Ulteriore complicazione deriva dal periodo di osservazione. Potrebbe, infatti, presentarsi al curatore una situazione occupazionale certa, ma tendente a trarre in inganno circa la procedura da seguire. Infatti, la situazione fotografata al momento dell’apertura della liquidazione giudiziale non è quella utile a individuare la corretta procedura da seguire, posto che ogni scelta deve seguire un preciso periodo di osservazione.
Al fine di individuare il periodo utile si dovrà scomodare la giurisprudenza, che solitamente lo individua in un anno mobile, ma non disdegna, in alcune pronunce, la forzatura verso periodi di normale occupazione più ampi.
[1] Pur in attesa della vacatio sospensiva che sposta questa modifica allo spirare dei 18 mesi successivi alla pubblicazione in G.U..
Si segnala che l’articolo è tratto da “Strumenti di lavoro“.
Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia: