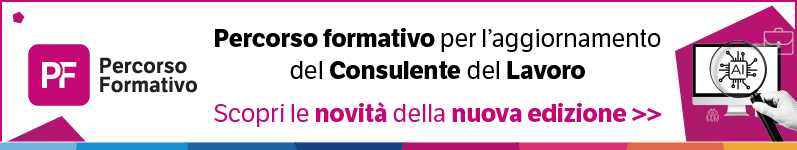Ragionevoli adattamenti e periodo di comporto
di Luca CarattiLuca Vannoni Scarica in PDF
Il rafforzarsi nel nostro ordinamento del ragionevole adattamento, a livello normativo come a livello giurisprudenziale, a cui si aggiunge una nuova definizione di disabilità, molto più fluida rispetto al quadro previgente, complica, e non di poco, la gestione del periodo di comporto e del relativo licenziamento, tenuto conto del ritardo della contrattazione collettiva nell’adeguare, al nuovo contesto, le proprie regolamentazioni in materia.
Il quadro normativo
Il tema dei ragionevoli accomodamenti appare, a livello comunitario, con la Direttiva del Consiglio, 27 novembre 2000, 2000/78/CE, articolo 5, dove si prevede che, per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento dei disabili, siano previste “soluzioni ragionevoli”, consistenti in provvedimenti appropriati del datore di lavoro, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, per consentire ai disabili “di accedere ad un lavoro, di svolgerlo o di avere una promozione o perché possano ricevere una formazione”, a meno che “richiedano da parte del datore di lavoro un onere finanziario sproporzionato. Tale soluzione non è sproporzionata allorché l’onere è compensato in modo sufficiente da misure esistenti nel quadro della politica dello Stato membro a favore dei disabili”.
La Direttiva è stata attuata nel nostro ordinamento con il D.Lgs. 216/2003, ma in modo assolutamente parziale, tanto che la Corte di Giustizia UE, con sentenza 4 luglio 2013, stabilì che la “Repubblica italiana, non avendo imposto a tutti i datori di lavoro di prevedere, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, soluzioni ragionevoli applicabili a tutti i disabili, è venuta meno al suo obbligo di recepire correttamente e completamente l’articolo 5 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”.
Secondo la CGUE, per trasporre correttamente e completamente l’articolo 5, Direttiva 2000/78/CE, non è sufficiente disporre misure pubbliche di incentivo e di sostegno, ma è compito degli Stati membri “imporre a tutti i datori di lavoro l’obbligo di adottare provvedimenti efficaci e pratici, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, a favore di tutti i disabili, che riguardino i diversi aspetti dell’occupazione e delle condizioni di lavoro…”.
Con l’espressione “disabile” la Corte, in assenza di una specifica definizione nella Direttiva, richiamava quanto stabilito dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità 13 dicembre 2006 (articolo 1), attuata nel nostro ordinamento nel 2009, a seguito della ratifica, mediante la L. 18/2009: “coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri”.
Per porre rimedio alla sentenza di condanna, il Governo, con l’articolo 9, comma 4, D.L. 76/2013 (convertito in L. 99/2013), aggiunse il comma 3-bis all’articolo 3, D.Lgs. 216/2003, dove si prevede che “al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad adottare accomodamenti ragionevoli, come definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, nei luoghi di lavoro, per garantire alle persone con disabilità la piena eguaglianza con gli altri lavoratori”.
Tornando, quindi, alla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità (articolo 2), per accomodamento ragionevole si intendono “le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali”.
Alla nozione di accomodamento ragionevole contenuta nell’articolo 2 si aggancia poi l’articolo 27, lettera i), Convenzione, dove si prevede che “gli Stati Parti devono garantire e favorire l’esercizio del diritto al lavoro, anche a coloro i quali hanno subìto una disabilità durante l’impiego, prendendo appropriate iniziative – anche attraverso misure legislative – in particolare al fine di: … i) garantire che alle persone con disabilità siano forniti accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro”.
A comporre il quadro, si deve ora aggiungere il recente intervento normativo innescato dalla legge delega in materia di disabilità 227/2021 e il recente provvedimento attuativo, il D.Lgs. 62/2024.
La riforma che si intende realizzare non può che essere collocata nell’ambito della disciplina comunitaria e internazionale citata in precedenza, come ammette direttamente il richiamo, all’articolo 1, L. 227/2021, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità 13 dicembre 2006, della comunicazione della Commissione Europea COM(2021) 101 final, del 3 marzo 2021 e della risoluzione del Parlamento Europeo del 7 ottobre 2021, sulla protezione delle persone con disabilità, formalizzando quanto discende dagli impegni della Repubblica Italiana a livello internazionale e comunitario.
Come finalità, il D.Lgs. 62/2024 intende attuare l’articolo 1, comma 5, lettere a), b), c), d) e h), L. 227/2021, per “assicurare alla persona il riconoscimento della propria condizione di disabilità, per rimuovere gli ostacoli e per attivare i sostegni utili al pieno esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, delle libertà e dei diritti civili e sociali nei vari contesti di vita, liberamente scelti”.
L’articolo 2, D.Lgs. 62/2024, definisce la condizione di disabilità come “una duratura compromissione fisica, mentale, intellettiva, del neurosviluppo o sensoriale che, in interazione con barriere di diversa natura, può ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri”.
L’articolo 4 provvede, poi, a sostituire, in un’ottica di effettiva parità anche a livello terminologico, parole discriminanti, ovunque ricorrano (persona handicappata, portatore di handicap, persona affetta da disabilità, disabile, diversamente abile) con “persona con disabilità”[1].
Rimanendo al tema del presente commento, l’articolo 17, al fine di riconoscere l’accomodamento ragionevole e predisporre misure idonee per il suo effettivo esercizio, interviene sulla L. 104/1992, inserendo il nuovo articolo 5-bis: l’accomodamento ragionevole, ai sensi dell’articolo 2, Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, è il parametro per valutare e individuare le misure e gli adattamenti necessari, pertinenti, appropriati e adeguati, che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo al soggetto obbligato.
Il comma 3 riconosce alla persona con disabilità, con apposita istanza scritta, la facoltà di richiedere l’adozione di un accomodamento ragionevole, anche formulando una proposta.
Il comma 5 fornisce, poi, ulteriori sfaccettature dell’accomodamento ragionevole: deve risultare “necessario, adeguato, pertinente e appropriato rispetto all’entità della tutela da accordare e alle condizioni di contesto nel caso concreto”, nonché “compatibile con le risorse effettivamente disponibili allo scopo”.
Il comma 11 prevede che, in caso di rifiuto da parte di un soggetto privato dell’accomodamento ragionevole, richiesto ai sensi del comma 3, l’istante e le associazioni legittimate ad agire ai sensi dell’articolo 4, L. 67/2006, ferma restando la facoltà di agire in giudizio ai sensi della medesima legge, possono chiedere all’Autorità garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità di verificare la discriminazione di rifiuto di accomodamento ragionevole.
Ragionevole adattamento nella giurisprudenza
Il tema del ragionevole adattamento ha visto, poi, intersecare la sua parabola con i recenti orientamenti in materia di comporto. In particolare, a partire dal 2023 la Corte di ha più volte affermato la natura discriminatoria del licenziamento per superamento del periodo di comporto, nel caso in cui non preveda alcuna regolamentazione specifica sulla base delle circostanze che determinano la malattia: “rispetto a un lavoratore non disabile, il lavoratore disabile è esposto al rischio ulteriore di assenze dovute a una malattia collegata alla sua disabilità, e quindi soggetto a un maggiore rischio di accumulare giorni di assenza per malattia e di raggiungere i limiti massimi di cui alla normativa pertinente” (Cassazione n. 9095/2023).
Il retroterra di tale orientamento di legittimità è l’acceso dibattito giurisprudenziale a livello di merito[2], innescatosi sulla base di alcune importanti pronunce della CGUE, in particolare CGUE HK Danmark 11 aprile 2013 (cause riunite C‑335/11 e C‑337/11) e Ruiz Conejero 18 gennaio 2018 (causa C-270/16), richiamate espressamente dalla Suprema Corte.
Nella prima sentenza della Corte di Giustizia UE, dalla considerazione che “la disabilità è un concetto in evoluzione e che la disabilità è il risultato dell’interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri”, si è affermato che “rispetto ad un lavoratore non disabile, un lavoratore disabile è esposto al rischio ulteriore di una malattia collegata al suo handicap”: la nozione di disabilità ricavabile dalla Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, come in precedenza evidenziato, include, infatti, anche una condizione patologica causata da una malattia, curabile o incurabile che sia, se comporta una limitazione in tali termini.
Conseguentemente, – prosegue la CGUE – si determina un trattamento discriminatorio ai sensi dell’articolo 2, § 2, lettera b), Direttiva 2000/78/CE, basato sulla disabilità nel caso in cui vi sia una disciplina del comporto che non tenga conto di tale situazione di svantaggio per i soggetti con disabilità, a meno che tale disparità di trattamento “sia oggettivamente giustificata da una finalità legittima, se i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e se essi non vadano al di là di quanto necessario per conseguire l’obiettivo perseguito dal legislatore”.
Nella seconda sentenza richiamata dalla Suprema Corte, Carlos Enrique Ruiz Conejero 18 gennaio 2018, C-270/16, la CGUE ha ribadito che la definizione di discriminazione indiretta contenuta nella Direttiva UE osta “a una normativa nazionale che consenta il licenziamento di un lavoratore in ragione di assenze intermittenti dal lavoro giustificate e dovute a malattie imputabili alla disabilità di cui soffre il lavoratore, salva verifica di quanto necessario per raggiungere l’obiettivo legittimo di lotta contro l’assenteismo”.
La normativa in questione, l’articolo 52 dello Statuto dei Lavoratori spagnolo (Real Decreto Legislativo 1/1995, Ley del Estatuto de los Trabajadores), pur prevedendo che talune assenze non siano da computare (ad esempio, terapia medica per patologia oncologica o altra grave patologia), non fissa alcun regime in deroga per tutte le situazioni di disabilità ai sensi della Direttiva 2000/78/CE.
Alla luce di tali orientamenti, con la Cassazione n. 9095/2023, sono stati affermati importanti principi: se è vero che la nozione di disabilità “non è coincidente con lo stato di malattia, oggetto della regolazione contrattuale collettiva applicata al rapporto ai fini del computo del periodo di comporto rilevante ai sensi dell’art. 2110 c.c.”, ciò non sta a significare che essa sia contrapposta a tale stato, che può esserne tanto causa quanto effetto, e le cui interazioni devono essere tenute in considerazione nella gestione del rapporto di lavoro.
Il caso riguardava un dipendente, con mansioni di spazzino stradale o spazzino porta-sacchi, riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3, comma 1, L. 104/1992, e licenziato per superamento del periodo di comporto: tale licenziamento era stato considerato nei gradi di merito come discriminatorio, dovendosi presumere (nonostante l’invio, non riscontrato dal lavoratore, di avviso dell’approssimarsi del comporto) che le assenze per malattia fossero riconducibili alla situazione di disabilità del lavoratore per l’assegnazione a mansioni incompatibili con il suo stato di salute.
Più in particolare, la letterale applicazione da parte del datore di lavoro dell’articolo 42, Ccnl Federambiente, al lavoratore licenziato, che non distingue tra assenze per malattia e assenze per patologie correlate alla disabilità, si era posta in palese contrasto con i principi espressi dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE richiamata in precedenza, alla luce del grave quadro patologico del lavoratore, qualificabile come disabilità ai sensi della Direttiva 2000/78/CE.
In modo estremamente repentino, sono seguite ulteriori sentenze di legittimità, conformi nell’impostazione a Cassazione n. 9095/2023, ma con ulteriori precisazioni e specifiche.
Con la Cassazione n. 11731/2024 è stato affrontato il caso del superamento del periodo di comporto, con conseguente licenziamento, di un lavoratore affetto da una patologia oncologica, sulla base della previsione contenuta nell’articolo 21, Ccnl Porti, che prevedeva un unico e indifferenziato periodo di comporto, a cui poi si aggiungeva un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita, sempre indifferenziata per lavoratori normodotati e con disabilità.
In primo luogo, la Suprema Corte non solo ricostruisce il comporto come “punto di equilibrio fra l’interesse del lavoratore a disporre d’un congruo periodo di assenze per ristabilirsi a seguito di malattia o infortunio e quello del datore di lavoro di non doversi fare carico a tempo indefinito del contraccolpo che tali assenze cagionano all’organizzazione aziendale”, ma lo sistematizza nell’alveo dei “ragionevoli accomodamenti”, come forma di adattamento organizzativo ai fini della legittimità del recesso.
In secondo luogo, la Cassazione richiama il precedente della sentenza n. 9095/2023, dando per assodato che l’applicazione dell’ordinario periodo di comporto al lavoratore disabile costituisce una forma di discriminazione indiretta.
In tale contesto, affinché vi sia un effettivo rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità, dev’essere applicato ogni ragionevole accomodamento organizzativo che, senza oneri finanziari sproporzionati, contemperi gli interessi del lavoratore e del datore di lavoro.
Rispetto ai precedenti, Cassazione n. 11731/2024 concentra le proprie attenzioni anche alla sfera del lavoratore: il comporto, come del resto i ragionevoli accomodamenti, è un punto di equilibrio tra istanze contrapposte.
In particolare, si evidenzia come ricada sul lavoratore l’onere “di allegare e provare la limitazione risultante dalle proprie menomazioni fisiche, mentali e psichiche durature e la traduzione di tale limitazione, in interazione con barriere di diversa natura, in un ostacolo alla propria partecipazione, piena ed effettiva, alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori”, così da consentire al datore di lavoro di adottare i concreti ragionevoli adattamenti, posto che non ogni situazione di infermità fisica che renda il lavoratore inidoneo alle mansioni di assegnazione risulta ex se riconducibile alla nozione di disabilità di cui alla disposizione suddetta.
In assenza di oneri di collaborazione del lavoratore, stante anche il fatto che le diagnosi non sono, com’è noto, conosciute dal datore di lavoro, la responsabilità in caso di omissioni nell’applicazione di ragionevoli accomodamenti sarebbe, di fatto, “oggettiva”.
A livello probatorio, inoltre, la Suprema Corte ricorda che nei procedimenti legati alla tutela antidiscriminatoria non vi è “un’inversione dell’onere probatorio, ma solo un’attenuazione del regime probatorio ordinario in favore del ricorrente, prevedendo a carico del datore di lavoro … l’onere di fornire la prova dell’inesistenza della discriminazione, ma a condizione che il ricorrente abbia previamente fornito al giudice elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, anche se non gravi, la presunzione dell’esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori” (Cassazione n. 25543/2018).
Nei fatti, il datore di lavoro era risultato a conoscenza della patologia del lavoratore e, pertanto, avendo comunque applicato meccanicamente la regola ordinaria in materia di comporto, è risultato inadempiente in ordine ai ragionevoli accomodamenti, da cui la natura discriminatoria del licenziamento, confermata dalla Suprema Corte, così come la reintegra derivante dalla nullità del recesso.
Sulla stessa linea si assesta la più recente Cassazione n. 15723/2024: oggetto della pronuncia, il licenziamento per superamento del periodo di comporto – Ccnl Multiservizi – di una lavoratrice affetta da patologia oncologica, di cui era a conoscenza il datore di lavoro.
Tra i motivi del ricorso in Cassazione presentato dal datore di lavoro, si sottolinea che il periodo di comporto nel Ccnl Multiservizi (365 giorni nell’arco di 36 mesi), essendo particolarmente lungo, rappresenta “di per sé un accomodamento ragionevole a tutela dei disabili in quanto garantisce la conservazione del posto di lavoro per un periodo di tempo compatibile anche con le patologie più gravi”.
Al comporto si aggiunge poi la previsione di una aspettativa non retribuita, di 4 mesi, sempre rivolta a tutti i lavoratori.
Nel rigettare il ricorso, la Cassazione puntualizza come, nell’applicare una tutela antidiscriminatoria, non sia la durata del periodo di comporto prevista per la generalità dei dipendenti che può eliminare o ridurre la condizione di svantaggio dei lavoratori con disabilità, in quanto si troverebbero comunque in una condizione di svantaggio legata al maggior rischio di ammalarsi. Nello stesso modo, anche l’aspettativa non retribuita è stata giudicata come rimedio non idoneo a elidere la situazione di svantaggio in cui il lavoratore con disabilità può trovarsi rispetto agli altri lavoratori.
Lapidario è il principio al § 17 della sentenza in commento: “la contrattazione collettiva che, come quella oggetto di causa, stabilisce un identico periodo di durata del comporto per tutti i lavoratori, senza prendere in specifica considerazione la posizione di svantaggio del disabile e senza adottare gli accomodamenti ragionevoli prescritti dalla Direttiva 2000/78/CE e dall’art. 3 comma 3 bis D.Lgs. n. 216/2003, realizza una discriminazione indiretta”.
Contrattazione collettiva e ragionevole adattamento
A fronte dell’orientamento giurisprudenziale, come sopra descritto, che riscontra l’indiretta discriminatorietà, laddove non sia prevista, nei contratti collettivi nazionali di categoria, una differenziazione del comporto per i lavoratori affetti da disabilità, si registra una sostanziale inerzia della contrattazione sul tema.
In particolare, su 59[3] rinnovi di contratti di categoria risulta che solo 10 sono intervenuti per prevedere clausole di estensione del periodo di comporto. Più precisamente, sono solo 3 i rinnovi che hanno fatto uno specifico riferimento alla disabilità, mentre i restanti 7 dispongono una tutela rafforzata nel caso in cui il lavoratore sia affetto da una malattia di particolare gravità (patologia oncologica, ictus, morbo di Cooley, etc.). Nell’analisi effettuata da Adapt[4], i contratti collettivi che sono stati sensibili a recepire il nuovo orientamento della giurisprudenza sono:
- Ccnl Assopellettieri;
- Ccnl Trasporto aereo;
- Ccnl Abi;
- Ccnl Federcasse (dirigenti);
- Ccnl Federcasse (quadri direttivi e delle aree professionali);
- Ccnl Confederazione italiana dello sport (Confcommercio);
- Ccnl Anpas e Misericordie;
- Ccnl Federalimentare;
- Ccnl Unic;
- Ccnl Alimentari cooperative.
Le parti sociali sono intervenute lungo 2 direttrici:
- da una parte, nel definire la platea dei lavoratori destinatari del comporto differenziato;
- dall’altra, nell’individuare le tecniche da adottare per garantire l’estensione del comporto.
Per quanto riguarda il primo aspetto, si riscontra che alcuni contratti si limitano ad allargare le maglie del precedente elenco delle patologie che consentono al lavoratore di fruire di un comporto differenziato, mentre altri sono intervenuti ampliando, in ossequio alla Cassazione sopra richiamata, il novero dei lavoratori beneficiari di un periodo di tutela prolungato tramite il recepimento della nozione di disabilità. Tali Ccnl utilizzano il criterio distintivo, nella selezione tra comporto ordinario e prolungato, dell’accertamento della disabilità e non l’insorgenza di una specifica malattia. Sul punto è da rilevare come il Ccnl per gli addetti alle concerie (Unic) abbia introdotto, nel rinnovo del 7 marzo 2024, un’estensione della tutela orientata dall’intervento della CGUE, 11 aprile 2013, cause riunite C-335/11 e C-337/11, la quale riconduce nella nozione di disabilità alcune malattie curabili o incurabili.
Così recita il testo contrattuale: “I termini sopra indicati sono aumentati rispettivamente di 2 mesi, 3 mesi e 4 mesi, per il lavoratore affetto da una condizione patologica causata da una malattia diagnosticata come curabile o incurabile, che comporti una limitazione, risultante da menomazioni fisiche, mentali, psichiche, in grado di ostacolare la piena ed effettiva partecipazione del lavoratore alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori e che sia di lunga durata. A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono casi di malattie invalidanti ed inabilitanti di lunga durata in grado di ostacolare la effettiva partecipazione del prestatore alla vita professionale come sopra definiti i seguenti:
a) morbo di Parkinson
b) malattie oncologiche
c) sclerosi multipla
d) neoplasia cerebrale
e) patologie cronico – degenerative di difficile trattamento e cura con le comuni terapie. “
Altri contratti collettivi (CCNL Abi) estendono il periodo di comporto a quei lavoratori per i quali “la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno è intensivo e determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”[5].
Altri ancora (Ccnl Federalimentari) prevedono l’estensione del comporto per i lavoratori disabili certificati ai sensi della L. 68/1999 ovvero quelle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, le persone invalide del lavoro con grado di invalidità superiore al 33%, non vedenti e sordomute, gli invalidi di guerra, civili di guerra.
Più precisamente, il Ccnl recita: “Le Parti convengono che i termini di conservazione del posto durante la malattia previsti al punto 1 del presente articolo sono aumentati di 90 giorni per il lavoratore con disabilità certificata ai sensi della L. n. 68/1999”[6].
Di fatto, quindi, l’accomodamento ragionevole introdotto dal contratto collettivo si limita ad aumentare di 90 giorni la durata del comporto ordinario, previsto nella misura di 186 giorni per lavoratori con anzianità fino a 5 anni compiuti e nella misura di 365 giorni per lavoratori con anzianità oltre i 5 anni compiuti.
Infatti, il medesimo contratto precisa che “durante il periodo ulteriore di conservazione del posto, non decorrerà retribuzione né si avrà decorrenza di anzianità per alcun istituto”.
A parere di chi scrive, la mera previsione di un “allungamento” del comporto senza decorrenza della retribuzione non pare garantire, anche sulla scorta dell’orientamento eurounitario, la piena esclusione dall’ipotesi di discriminazione indiretta del lavoratore disabile.
Il già citato Ccnl Abi prevede, poi, che il comporto differenziato venga realizzato mediante un aumento del 50% del periodo di comporto ordinario indicato per singolo lavoratore in base all’anzianità e, comunque, che vada da un minimo di 12 mesi a un massimo di 30 mesi.
La riservatezza della patologia
Nell’applicazione del periodo di comporto capita di doversi interrogare circa la conoscibilità, da parte del datore di lavoro, della patologia sofferta dal lavoratore, che potrebbe comportare l’applicazione di un periodo di tutela differenziato. È, infatti, pacifico affermare che, stante l’orientamento della giurisprudenza[7], contrasta con la normativa posta a tutela sulla privacy il fatto che nella copia del referto medico destinata al datore di lavoro sia riportata esplicitamente la patologia dalla quale risulta affetto il dipendente. Stante la riservatezza da utilizzare in presenza di dati sensibili come quelli sulla salute, infatti, il datore è tenuto a conoscere esclusivamente la conferma della prognosi da parte del medico. Con ciò, quindi, si esclude che il datore di lavoro possa conoscere, tramite certificazione, la patologia del lavoratore, fatte salve le tutele alla persona nell’ambito della sorveglianza sanitaria. Al fine di risolvere, quantomeno sul piano contrattuale, la problematica emarginata, il Ccnl Unic prevede che: “Per i principi di buona fede nel rapporto contrattuale di lavoro, la disposizione del precedente periodo (prolungamento comporto, ndA) trova applicazione esclusivamente a condizione che il lavoratore, fermo restando l’assoluto rispetto della normativa cogente in materia di privacy, abbia comunicato in anticipo al datore di lavoro la natura invalidante della malattia in grado di giustificare l’estensione del termine di garanzia del posto”[8].
Tale previsione mira, come giustamente osservato[9], “a garantire un bilanciamento tra la tutela del lavoratore disabile e la disciplina in materia di riservatezza, poiché subordina l’estensione del periodo di comporto all’effettiva conoscibilità della condizione soggettiva del lavoratore da parte del datore di lavoro, sottolineando l’importanza degli obblighi di buona fede e correttezza nell’esecuzione del rapporto di lavoro”.
In realtà, prosegue ancora, “la più recente giurisprudenza di legittimità, proprio nella ricerca del bilanciamento tra la tutela del lavoratore disabile e la necessità di non incorrere in forme di responsabilità oggettiva del datore di lavoro ha avuto modo di precisare, discostandosi parzialmente da un precedente orientamento che riteneva che la discriminazione operasse in tutti i casi obiettivamente e a prescindere dalla volontà illecita del datore di lavoro di discriminare, che sussiste in capo al datore, prima di adottare il provvedimento di licenziamento per superamento del periodo di comporto, l’onere di acquisire informazioni circa l’eventualità che le assenze siano connesse alla condizione di disabilità (a cui comunque non può corrispondere un comportamento ostruzionistico da parte del lavoratore). In questo senso, dunque, la clausola del CCNL Unic potrebbe apparire come riduttiva, poiché accorda l’estensione del periodo di comporto ai soli casi in cui il lavoratore abbia comunicato al datore la propria condizione soggettiva, ma non considera la possibilità per cui il datore, adottando comportamenti diligenti, avrebbe comunque potuto rendersi edotto circa lo stato di salute del dipendente”[10].
Conclusioni
Dall’analisi[11] emerge come ancora la contrattazione collettiva, nonostante il tema degli accomodamenti ragionevoli sia stato estrinsecato dalla Cassazione ormai da un anno, nei rinnovi non sia stata particolarmente reattiva a recepirne le indicazioni. Più nello specifico, nella quasi totalità dei contratti rinnovati viene limitata la fruizione del comporto differenziato solo ai lavoratori la cui patologia grave è insorta in costanza di lavoro. Tale limitazione non esclude, a rigore, il rischio di una lamentazione di discriminazione indiretta, in quanto non sarebbe accordabile, ai lavoratori a cui la patologia è sorta ante instaurazione rapporto di lavoro, il comporto prolungato.
In ultimo, si osserva come le medesime parti sociali non abbiano accordato la tutela a tutto lo spettro dei lavoratori che ne potrebbero avere diritto, ma essa sia stata riservata solo a coloro i quali rientrano nell’appartato definitorio contenuto nell’articolo 3, comma 3, L. 104/1992, e nell’articolo 1, comma 1, L. 68/1999. Va da sé, quindi, che i datori di lavoro, in attesa di eventuali soluzioni previste dai Ccnl che mano a mano recepiranno le sollecitazioni della giurisprudenza, saranno chiamati a introdurre misure di maggiore tutela in ordine alla conservazione dei posti per tutti quei soggetti che o appartengono alle categorie protette certificate o hanno patologie gravi note al datore di lavoro.
[1] L’articolo 4, D.Lgs. 62/2024, provvede poi a sostituire le parole “con connotazione di gravità” e “in situazione di gravità”, ove ricorrono e riferite a persone con disabilità, con “con necessità di sostegno elevato o molto elevato»; le parole: «disabile grave», ove ricorrono, con “persona con necessità di sostegno intensivo”.
[2] E. Dagnino, “Comporto, disabilità e disclosure: note a margine di una querelle giurisprudenziale”, ADL n. 1/2023, pag. 241.
[3] F. Alifano “Discriminazione per disabilità, comporto e contrattazione collettiva”, Working paper n. 7/2024, Adapt.
[4] Si veda nota 3.
[5] Articolo 3, comma 3, L. 104/1992.
[6] Articolo 47, Ccnl Federalimentari (Alimentari industria).
[7] Cassazione n. 2367/2018.
[8] Articolo 60, Ccnl Unic.
[9] Si veda nota 2.
[10] Si veda ancora nota 2.
[11] Si veda ancora nota 2.
Si segnala che l’articolo è tratto da “La circolare di lavoro e previdenza”