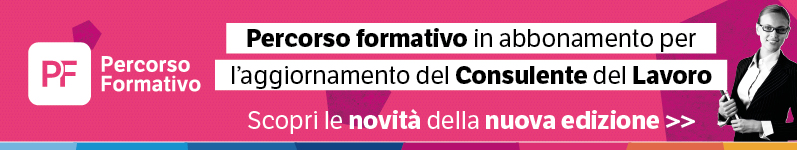Licenziamento “per profitto”: il punto della giurisprudenza
di Edoardo Frigerio
La più recente giurisprudenza di legittimità ha, con orientamento che si è consolidato negli ultimi mesi, stabilito che non occorre una situazione di crisi o difficoltà economica dell’impresa per procedere a un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ma che si può licenziare anche per migliorare l’organizzazione o la reddittività dell’impresa, quindi anche “per profitto”. Liberalizzazione, quindi, del licenziamento per motivi economici? Non è proprio esattamente così, come si rileva in alcune recenti sentenze di merito che denotano l’esistenza di vincoli ancora piuttosto rigidi in caso di licenziamento per gmo.
Il licenziamento “per profitto”
Il giorno di S. Ambrogio del 2016, mentre la maggior parte degli italiani erano alacremente impegnati nella ricerca di strenne nei mercatini natalizi, una sentenza della Cassazione balzava alle cronache nazionali, squassando la serena atmosfera festiva di lavoratori e datori.
I giornali subito davano larga eco all’evento con titoli a carattere cubitali: “Cassazione, legittimo licenziare per aumentare i profitti”; “Cassazione, licenziamento legittimo se l’azienda vuole aumentare i profitti”; “Cassazione, sì al licenziamento per aumentare il profitto”.
L’epocale sentenza in questione era la pronuncia n. 25201/2016 e nel frattempo sono passati alcuni mesi dalla pronuncia: la Cassazione ha così avuto modo di pronunciarsi altre volte sullo scottante tema del licenziamento “per profitto”, da ultimo con la recente sentenza n. 13015/2017.
Diversi interrogativi si pongono quindi ai prudenti operatori del diritto: si può licenziare per mere esigenze di maggiore profitto aziendale? Oppure il licenziamento è ancora oggi, per il datore di lavoro, un’extrema ratio? É vero quindi quello che si legge su internet sul libero licenziamento “per profitto” o si tratta di fake news?
Per poter cercare di dare una risposta a tali quesiti amletici occorre quindi prendere cognizione dell’attuale “stato dell’arte” giurisprudenziale: come spesso accade le risposte non paiono né semplici né univoche.
Prendendo quindi le mosse, in ordine cronologico, dalla sentenza di “S. Ambrogio” sopra indicata, si nota subito come nella pronuncia n. 25201/2016 la vicenda in fatto, utile per rendersi effettivamente conto della reale portata della sentenza, sia appena accennata: una società toscana aveva licenziato nel 2013 un lavoratore per gmo, in considerazione della soppressione della sua posizione lavorativa dovuta all’esigenza di “rendere più snella la c.d. catena di comando e quindi la gestione aziendale“. Impugnato il licenziamento, mentre il giudice di primo cure aveva affermato la legittimità del licenziamento, la Corte d’Appello di Firenze – evidenziando preliminarmente che, in mancanza di prova da parte del datore di lavoro dell’esigenza di fare fronte a sfavorevoli e non meramente contingenti situazioni influenti in modo decisivo sulla normale attività produttiva ovvero per sostenere notevoli spese di carattere straordinario, ogni riassetto dell’impresa risulterebbe motivato soltanto dalla riduzione dei costi e, quindi, dal mero incremento del profitto – in mancanza della dimostrazione dell’effettività della riorganizzazione, riteneva illegittimo il licenziamento, dichiarando risolto il rapporto di lavoro e condannando la società a corrispondere al lavoratore 15 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto (al licenziamento era infatti applicato l’articolo 18, L. 300/1970, nella sua formulazione post L. 92/2012).
Il datore di lavoro ricorreva in Cassazione contestando che, ove la soppressione della funzione fosse stata dettata da una mera scelta di una più economica gestione dell’impresa, tale decisione aziendale sarebbe comunque legittima, in quanto attinente alla libertà economica dell’imprenditore poiché, ai fini della giustificazione del motivo oggettivo di licenziamento, non dovrebbe sussistere il requisito economico dato dall’esistenza di sfavorevoli situazioni o dalla necessità di sostenere notevoli spese straordinarie.
La Suprema Corte, chiamata alla decisione, ha, nella sentenza n. 25201/2016, ricostruito le posizioni giurisprudenziali sul punto, sottolineando l’esistenza di un primo orientamento, in base al quale il presupposto fattuale della sfavorevole situazione economica in cui versa l’azienda, indipendentemente dalle ragioni addotte dall’imprenditore e dalla loro effettività, assurge a requisito di legittimità intrinseco al licenziamento per giustificato motivo oggettivo che deve essere provato dal datore di lavoro e accertato dal giudice. Tale orientamento, che afferma quindi che il licenziamento per motivo oggettivo debba essere giustificato dalla necessità di fare fronte “a sfavorevoli situazioni” e non sia “meramente strumentale a un incremento del profitto“, si trova, come evidenzia la sentenza n. 25201/2016, in un numero piuttosto considerevole di sentenze anche recenti.
Avverso a questo orientamento, la pronuncia ha sottolineato l’esistenza di un secondo indirizzo, in base al quale le ragioni inerenti all’attività produttiva, indicate nell’articolo 3, L. 604/1966, possono derivare anche da riorganizzazioni o ristrutturazioni, quali ne siano le finalità e quindi comprese quelle dirette al risparmio dei costi o all’incremento dei profitti: ciò poiché, in caso contrario, l’organizzazione aziendale, una volta delineata, costituirebbe un dato non modificabile se non in presenza di un andamento negativo e non anche ai fini di una più proficua configurazione dell’apparato produttivo; inoltre si è considerato estraneo al controllo giudiziale il fine dell’arricchimento, o non impoverimento, perseguito dall’imprenditore, comunque suscettibile di determinare un incremento di utili a beneficio dell’impresa e, dunque, dell’intera comunità dei lavoratori.
La sentenza n. 25201/2016 ha quindi operato una sintesi delle opposte posizioni giurisprudenziali, evidenziando che:
- i tratti comuni a entrambi gli orientamenti sono rappresentati dal controllo giudiziale sull’effettività del ridimensionamento e sul nesso causale tra la ragione addotta e la soppressione del posto di lavoro del dipendente licenziato;
- il secondo orientamento illustrato deve, però, considerarsi prevalente: infatti l’interpretazione letterale dell’articolo 3, L. 604/1966, esclude che, per ritenere giustificato il licenziamento per motivo oggettivo, debba ricorrere, ai fini dell’integrazione della fattispecie astratta, un presupposto fattuale identificabile nella sussistenza di “situazioni sfavorevoli” ovvero di “spese notevoli di carattere straordinario“, cui il datore di lavoro debba far fronte;
- infatti è sufficiente che il licenziamento sia determinato da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa, tra le quali non possono essere aprioristicamente escluse quelle che attengono a una migliore efficienza gestionale o produttiva ovvero quelle dirette a un aumento della redditività d’impresa: non è quindi necessario che si debba fronteggiare un andamento economico negativo o spese straordinarie e non appare immeritevole di considerazione l’obiettivo aziendale di salvaguardare la competitività nel settore nel quale si svolge l’attività dell’impresa attraverso le modalità, e quindi la combinazione dei fattori della produzione, ritenute più opportune dal datore di lavoro;
- in assenza di una specifica indicazione normativa, la tutela del lavoro garantita dalla Costituzione non consente di riempire di contenuto la L. 604/1966, articolo 3, sino al punto di ritenere precettivamente imposto che, nel dilemma tra una migliore gestione aziendale e il recesso da un singolo rapporto di lavoro, l’imprenditore possa optare per la seconda soluzione solo a condizione che debba fare fronte a sfavorevoli e non contingenti situazioni di crisi;
- non pare dubbio che spetti all’imprenditore stabilire la dimensione occupazionale dell’azienda, evidentemente al fine di perseguire il profitto che è lo scopo lecito per il quale intraprende l’attività imprenditoriale. Tale scelta è sicuramente libera nel momento genetico in cui nasce l’azienda e si instaurano i rapporti di lavoro in misura ritenuta funzionale allo scopo; anche durante la vita dell’azienda la selezione del livello occupazionale dell’impresa rimane libera;
- bisogna sempre ricordare che, in base all’articolo 30, comma 1, L. 183/2010, in tutti i casi nei quali le disposizioni di legge nella materie del lavoro privato e pubblico contengano clausole generali, ivi comprese le norme in tema di recesso, il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai principi generali dell’ordinamento, all’accertamento del presupposto di legittimità e non può essere esteso al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro.
La sentenza n. 25201/2016 giunge quindi a individuare le seguenti regole, applicabili al licenziamento per “motivi economici”:
- la ragione inerente all’attività produttiva e all’organizzazione del lavoro è quella che determina un effettivo ridimensionamento riferito alle unità di personale impiegate in una ben individuata posizione lavorativa;
- la modifica della struttura organizzativa può manifestarsi nella soppressione della funzione cui il licenziato era addetto, nella c.d. esternalizzazione della sua attività a terzi, nella ripartizione delle mansioni di questi tra più dipendenti già in forze, nell’innovazione tecnologica che rende superfluo il suo apporto;
- la circostanza che tali effetti di ristrutturazione organizzativa possano essere originati dall’obiettivo di una migliore efficienza gestionale o produttiva ovvero finalizzati a un incremento della redditività d’impresa (e quindi eventualmente del profitto) e non solo determinati dalla necessità di fare fronte a situazioni economiche sfavorevoli non contingenti non significa affatto che la decisione imprenditoriale sia sottratta a ogni controllo e sfugga a ben precisi limiti: non vi è infatti effettiva soppressione del posto di lavoro nel caso in cui avvenga una mera sostituzione del dipendente licenziato con altro lavoratore assunto, anche a minor costo, malgrado l’identità (o la sostanziale equivalenza) delle mansioni;
- resta viceversa possibile il controllo giudiziale sull’effettività e non pretestuosità della ragione concretamente addotta dall’imprenditore a giustificazione del recesso: se il licenziamento è quindi motivato dall’esistenza di una crisi aziendale o di un calo del fatturato e in giudizio si accerta, invece, che la ragione indicata non sussiste, tale recesso può essere dichiarato illegittimo dal giudice del merito per una valutazione in concreto sulla mancanza di veridicità o sulla pretestuosità della ragione addotta dall’imprenditore: l’inesistenza del fatto posto a fondamento del licenziamento, così come giudizialmente verificata, rende in concreto il recesso privo di effettiva giustificazione;
- deve comunque sempre essere verificato il nesso causale tra l’accertata ragione inerente all’attività produttiva e l’organizzazione del lavoro come dichiarata dall’imprenditore e l’intimato licenziamento in termini di riferibilità e di coerenza rispetto all’operata ristrutturazione: ove il nesso manchi, anche al fine di individuare il lavoratore colpito dal recesso, si rivela l’uso distorto del potere datoriale, emergendo una dissonanza che smentisce l’effettività della ragione addotta a fondamento del licenziamento.
La conclusione della monumentale sentenza n. 25201/2016 è che la combinazione di siffatti controlli e limiti – oltre alle comuni tutele del lavoratore dagli eventuali atti illeciti o discriminatori del datore – esclude che il potere di questi di risolvere il rapporto per motivazioni economiche possa essere assimilato a un recesso ad nutum, frutto di scelte unilaterali e insindacabili dell’imprenditore.
Veniva così cassata la sentenza del giudice d’appello impugnata, che, in mancanza di prova da parte del datore di lavoro dell’esigenza di fare fronte a sfavorevoli e non contingenti situazioni economiche ovvero per sostenere notevoli spese di carattere straordinario, aveva ritenuto non sufficiente ai fini della legittimità del licenziamento del lavoratore la dimostrazione dell’effettività della riorganizzazione attuata, che pure risultava coerente con la motivata esigenza tecnica di rendere più efficiente la gestione aziendale.
Le successive pronunce della Cassazione sino alla sentenza n. 13015/2017
Passato il clamore mediatico suscitato dalla sentenza n. 25201/2016, vediamo di seguito se e come successive sentenza della sezione lavoro della Cassazione abbiano fatto applicazione dei principi sanciti dalla pronuncia sopra esaminata.
La sentenza n. 4015/2017 ha confermato una pronuncia della Corte d’Appello di Bologna, che aveva reintegrato un lavoratore licenziato nel 2007.
In questo caso, conformemente alla sentenza n. 25201/2016, la sentenza ha preso le distanze da quelle pronunce che avevano ravvisato nell’andamento economico negativo dell’azienda un presupposto indispensabile del licenziamento per “motivi economici”, evidenziando che, ai fini della legittimità del licenziamento, sono sufficienti ragioni inerenti all’attività produttiva e all’organizzazione del lavoro, ivi comprese quelle dirette a una migliore efficienza gestionale ovvero a un incremento della redditività dell’impresa, purché idonee a determinare un effettivo mutamento dell’assetto organizzativo.
Nel caso di specie, però, il datore di lavoro non aveva dimostrato la veridicità della causale addotta al licenziamento per gmo, cosicchè non era ritenuta giustificata la riduzione del personale assegnato al settore commerciale con il richiamo, formulato nella lettera di licenziamento, a presunte difficoltà finanziarie e di mercato in realtà insussistenti: da ciò è conseguita la fatale decisione della reintegra piena nel posto di lavoro, essendo il licenziamento avvenuto sotto l’egida dell’articolo 18 anteriore alle modifiche della L. 92/2012 (nessuno dei casi esaminati atteneva infatti a rapporti di lavoro regolati dal Jobs Act).
Anche la pronuncia n. 10699/2017 ha espressamente richiamato la sentenza n. 25201/2016 (nonché quella appena esaminata), così riassumendo lo “stato dell’arte”: “sebbene la decisione imprenditoriale di ridurre la dimensione occupazionale dell’azienda possa essere motivata anche da finalità che prescindano da situazioni sfavorevoli e che perseguano l’obiettivo dell’aumento della redditività d’impresa, tuttavia è pur sempre necessario: che la riorganizzazione sia effettiva; che la stessa si ricolleghi causalmente alla ragione dichiarata dall’imprenditore; che il licenziamento si ponga in termini di riferibilità e di coerenza rispetto all’operata ristrutturazione”.
Anche nel caso di specie, nonostante le premesse, il giudizio si è concluso con la reintegrazione piena nel posto di lavoro (il licenziamento, questa volta, era del 2011), poiché il giudice di merito aveva correttamente valutato la non funzionalità della scelta aziendale di soppressione del posto occupato dal lavoratore e la contraddittorietà rispetto alla rilevata esistenza di una strategia aziendale di apertura agli investimenti e alle nuove assunzioni.
Da ultimo, nell’alveo formato dalle predette sentenze, si inserisce la recentissima sentenza n. 13015/2017. Nel caso di specie, un’azienda bresciana aveva licenziato un dipendente ripartendo le mansioni residuale ad altro dipendente in forza. Sia il Tribunale che la Corte d’Appello di Brescia rigettavano l’impugnazione del lavoratore, poiché era stata accertata la genuinità del riassetto organizzativo che aveva portato ad assegnare ad altro lavoratore (già da tempo in servizio e con maggiori carichi di famiglia) le mansioni in precedenza espletate dal dipendente posto in esubero. Al riguardo non rilevava l’eventuale esistenza di utili di bilancio della società, atteso che – recita la sentenza – in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo il datore di lavoro, nel procedere al riassetto della sua impresa, può ricercare il profitto mediante la riduzione del costo del lavoro o di altri fattori produttivi, fermo il limite che il suo obiettivo non può essere perseguito soltanto con l’abbattimento del costo del lavoro, ossia con il puro e semplice licenziamento di un dipendente non giustificato da un effettivo mutamento dell’organizzazione tecnico-produttiva, ma solo dal fine di sostituirlo con un altro meno retribuito, ancorché addetto alle medesime mansioni.
Pertanto il datore di lavoro non è tenuto a dimostrare l’esistenza di sfavorevoli situazioni di mercato – trattandosi di necessità non richiesta dall’articolo 3, L. 604/1966 – poiché, diversamente, si dovrebbe ammettere la legittimità del licenziamento soltanto ove esso tenda a evitare perdite di esercizio (e quindi, in prospettiva, a prevenire il rischio di fallimento dell’impresa) e non anche a migliorarne la produttività.
Conclude però la sentenza in esame che, in ogni caso, i principi espressi non esimono il giudice dal controllare che tale riorganizzazione, pur non sindacabile nel merito, nondimeno sia genuina (ossia effettiva e non meramente apparente o pretestuosa), preceda logicamente e/o cronologicamente il licenziamento stesso (altrimenti sarebbe mero effetto di risulta d’una scelta diversa da quelle tecnico-organizzative o produttive consentite) e derivi da necessità non meramente contingenti e transeunti (cioè non destinate a essere certamente riassorbite in un breve arco di tempo).
Il licenziamento “per profitto” è quindi sdoganato, ma Milano e Roma mettono dei “paletti”
Se i principi espressi dalla “storica” sentenza della Cassazione n. 25201/2016 sono stati, come visto, uniformemente seguiti dalla giurisprudenza successiva, sino a essere definitivamente scolpiti dalla recente pronuncia n. 13015/2017, è interessante verificare che ricaduta gli stessi abbiano avuto sulle pronunce di merito che tali principi applicano sul piano del caso concreto, laddove le valutazioni della Suprema Corte attengono, come noto, alla legittimità del giudizio.
Alcune pronunce di merito hanno infatti richiamato la sentenza n. 25201/2016 ma gli esiti non sono sempre quelli che ci potrebbero aspettare.
Il problema principale attiene infatti al nesso di causalità tra la riorganizzazione e il licenziamento, oltre all’effettività delle ragioni poste alla base del licenziamento. La regola vuole che il giudice non possa indagare sui motivi imprenditoriali che spingono il datore di lavoro a organizzare in un certo modo la propria attività e limitarsi alla verifica, appunto, dell’effettività delle ragioni del licenziamento, ma spesso gli effettivi confini entro i quali si può spingere l’indagine sono labili.
Al riguardo una pronuncia del Tribunale di Milano ha giudicato il caso di una riorganizzazione attuata da un’azienda e comportante la soppressione di una posizione lavorativa, in presenza di un preteso andamento negativo dell’attività. Nel caso specifico il giudice ambrosiano, pur richiamando uno dei principi espressi nella sentenza n. 25201/2016, ha affermato che la ragione del licenziamento non può essere costituita da un generico ridimensionamento dell’attività imprenditoriale, ma dalla necessità di procedere alla soppressione del posto o del reparto cui è addetto il singolo lavoratore, con la conseguenza – specialmente in complessi aziendali di rilevanti dimensioni – che la motivazione di un licenziamento per gmo non può essere lasciata a una giustificazione non specifica, che non renda cioè in particolare la ragione per la quale la crisi o l’operazione riorganizzativa dovrebbe concernere proprio quel lavoratore. Diversamente, una giustificazione fondata sulle sole cicliche crisi dell’impresa come tale, determinerebbe una ragione spendibile per qualunque lavoratore di qualunque reparto. Da queste considerazioni il Tribunale di Milano ha fatto discendere addirittura le conseguenze di cui all’articolo 18, comma 4, St. Lav., reintegrando il dipendente per manifesta insussistenza del fatto posto alla base del licenziamento per gmo.
Passando poi a una recentissima sentenza della sezione lavoro del Tribunale di Roma, si nota come la pronuncia del giudice capitolino presenti assonanze con quella del Tribunale milanese. Nel caso di specie una società, proprietaria di alcuni negozi di abbigliamento, aveva deciso il licenziamento di una commessa in considerazione del calo del fatturato della società e della necessità di riduzione dell’organico e dei costi. La lavoratrice impugnava il licenziamento, contestando la sussistenza di una crisi aziendale, in considerazione del miglioramento dei bilanci dell’ultimo periodo. Anche in questo caso il Tribunale ha richiamato i concetti espressi dalla Cassazione n. 25201/2016 (e successive pronunce) e, in particolare, la non obbligatorietà, quale presupposto di un licenziamento per gmo, di un andamento economico negativo del datore di lavoro, ma l’effettività del mutamento dell’assetto organizzativo. Il Tribunale di Roma non si soffermava quindi più tanto sui dati di bilancio, ma sul fatto che non era stato provato dal datore di lavoro il nesso causale tra la crisi che aveva comportato la riorganizzazione e l’intimato licenziamento, non essendo comprensibile quale sia stata la riorganizzazione effettuata dalla società in presenza della crisi aziendale che abbia dovuto comportare il licenziamento della ricorrente. In particolare il Tribunale capitolino precisava che il datore di lavoro può procedere alla riorganizzazione mediante la riduzione del costo del lavoro cercando di conseguire un maggiore profitto, ma tale obiettivo non può essere perseguito con il licenziamento di un solo dipendente in alcun modo giustificato dalla riorganizzazione tecnico produttiva, poiché, ha concluso il Tribunale, non si può parlare di riorganizzazione nel caso essa consista nell’eliminazione dello stipendio di un solo lavoratore.
L’ampia rassegna giurisprudenziale sopra esaminata può condurre all’affermazione che il presupposto della crisi economica o della difficoltà finanziaria non costituisce più un requisito necessario per il licenziamento per gmo (anche se in concreto avviene certo non di frequente che il datore di lavoro decida di rinunciare alla collaborazione di dipendenti senza un’effettiva necessità di riduzione dei costi del lavoro per fronteggiare situazioni avverse).
L’attenzione del datore di lavoro avveduto deve quindi spostarsi su due questioni essenziali: in primo luogo le motivazioni poste alla base del gmo devono essere sia sussistenti che specifiche; in secondo luogo deve essere dimostrato il nesso causale tra le motivazioni (ad esempio di natura riorganizzativa) e l’individuazione dell’esubero.
Insomma il licenziamento deve essere una conseguenza causalmente verificabile dell’attuata riorganizzazione o esigenza produttiva, senza poter invertire i fattori: quindi il datore deve prima riorganizzare e poi individuare gli effettivi esuberi, non può far coincidere la riorganizzazione con il licenziamento, specie se singolo.
È chiaro che, in tale modo, si viene nuovamente a porre in essere quel contrasto tra la libera iniziativa imprenditoriale del datore di lavoro e il diritto del lavoratore alla conservazione del posto che considera il licenziamento dello stesso quale extrema ratio.
In sostanza il datore di lavoro può organizzare la propria attività come meglio crede, senza che si possa sindacare giudizialmente le scelte datoriali, ma la scelta di continuare ad avvalersi di questo o quel dipendente soggiace ai limiti, piuttosto rigidi, sopra evidenziati: si è quindi ben lontani da quella totale libertà di azione che, ma solo nei titoli dei giornali, sembrava concessa agli imprenditori al momento di procedere al licenziamento per gmo.
Si segnala che l’articolo è tratto da “Il giurista del lavoro“.
Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia: