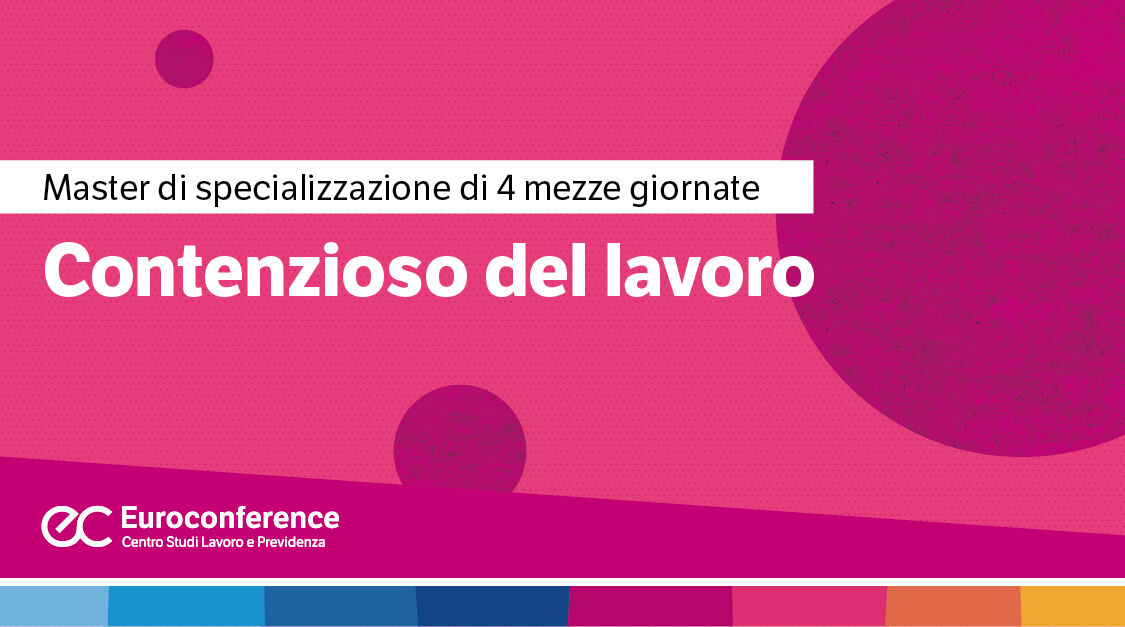Licenziamento (invalido) per superamento del comporto: reintegra anche nelle piccole aziende
di Evangelista BasileRosibetti Rubino
Con la sentenza n. 27334/2022, la Corte di Cassazione – ribaltando i primi gradi di giudizio – ha affermato che nel caso di mancato superamento del comporto, il licenziamento è da ritenersi nullo a prescindere dal dato occupazionale del datore di lavoro. A tale regime di nullità, però, consegue l’applicazione della tutela reintegratoria c.d. attenuata, ai sensi dell’articolo 18, comma 7, L. 300/1970, pur in caso di piccole aziende.
I fatti di causa
Nella vicenda in commento, infatti, un’azienda con meno di 15 dipendenti intimava il licenziamento per superamento del periodo di comporto avverso una lavoratrice che risultava assente dal lavoro per malattia per un numero di giorni complessivamente superiori al periodo di comporto previsto dal Ccnl applicato. La lavoratrice impugnava il licenziamento, contestando all’azienda datrice di lavoro di aver computato nel comporto alcuni giorni di assenza imputabili, invece, al comportamento del datore di lavoro e chiedeva, pertanto, la reintegrazione nel posto di lavoro. Durante la trattazione della causa, era emerso che alcune delle assenze per malattia della lavoratrice erano, in realtà, riconducibili a un infortunio sul lavoro imputabile alla responsabilità del solo datore di lavoro e, pertanto, i relativi giorni di assenza non potevano essere computati nel calcolo del periodo di comporto. Il Tribunale di Reggio Emilia accoglieva la domanda, dichiarava la nullità del licenziamento e condannava la società alla reintegra della lavoratrice e al risarcimento del danno nella misura di cui al combinato disposto dell’articolo 18, commi 4 e 7, St. Lav., come modificato dalla L. 92/2012. Proponeva, quindi, reclamo la società e la Corte d’Appello di Bologna, in parziale accoglimento dell’impugnazione e in parziale riforma della sentenza di I grado, condannava la parte datoriale a riassumere la lavoratrice entro 3 giorni o a corrisponderle, a titolo di risarcimento del danno, un’indennità pari a 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. La Corte d’Appello ha ritenuto, infatti, che la lettura data dal primo giudice si ponesse in contrasto con l’articolo 18, comma 8, St. Lav., che esplicitamente esclude l’applicazione dei commi da 4 a 7 al datore di lavoro privo dei requisiti dimensionali individuati nel medesimo comma 8. Con la conseguenza che il combinato disposto dell’articolo 18, commi 4 e 7, St. Lav., avrebbe dovuto considerarsi operante nei limiti della tutela c.d. reale e non applicabile ai licenziamenti intimati da datori di lavoro privi del requisito occupazionale, riconducendo il caso in esame alla previsione dell’articolo 8, L. 604/1966.
La lavoratrice ha, dunque, proposto ricorso in Cassazione, la quale, chiamata a individuare le corrette conseguenze sanzionatorie applicabili al licenziamento per superamento del periodo di comporto confermato illegittimo, ha evidenziato che la violazione dell’articolo 2110, cod. civ. – che inibisce al datore di lavoro l’esercizio del diritto di recedere dal contratto di lavoro prima della scadenza del periodo di comporto – integra una fattispecie di nullità del licenziamento espressamente tipizzata dall’articolo 18, L. 300/1970, come modificato dalla L. 92/2012.
In quanto nullità e non mera illegittimità, il recesso sarebbe, quindi, da ricondurre nell’alveo dell’articolo 18, comma 1, St. Lav., il quale – come noto – si applica a tutti i datori di lavoro, a prescindere dal requisito occupazionale. Il richiamo della violazione dell’articolo 2110, comma 7, cod. civ., dunque, sarebbe solo previsto in funzione delle conseguenze sanzionatorie che il Legislatore ha voluto introdurre per la specifica ipotesi.
In punto di regime di tutela applicabile, dunque, la Suprema Corte ha precisato che – ferma la riconducibilità di tale tipologia di vizio del recesso a quella della nullità e dunque al comma 1 – le conseguenze sarebbero, invece, da rinvenirsi nel regime sanzionatorio speciale dell’articolo 18, comma 7, St. Lav., che a sua volta rinvia al comma 4 e che prevede la sanzione della reintegrazione nel posto di lavoro e il pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, in misura non superiore a 12 mensilità.
Ciò comporta, pertanto, a detta della Corte di Cassazione, l’irrilevanza del criterio selettivo basato sul numero dei dipendenti che, se può giustificare livelli diversi di tutela in ipotesi di licenziamento annullabile, non può legittimare una diversificazione delle conseguenze del licenziamento nullo. Secondo la Suprema Corte, questa sarebbe la sola interpretazione compatibile con l’esigenza di garantire razionalità e armonia al sistema delle tutele nel caso di licenziamento.
La normativa di riferimento
La fattispecie in esame si colloca, ratione temporis, nell’ambito di applicazione dell’articolo 18, St. Lav., come modificato dalla L. 92/2012.
Come noto, prima della c.d. Riforma Fornero, infatti, all’illegittimità del licenziamento discendeva un’unica tipologia di tutela (quale che fosse la ragione della dichiarazione di illegittimità): la tutela reale forte, ovvero la reintegrazione del lavoratore e il risarcimento pieno del danno. Il datore di lavoro, quindi, era in ogni caso condannato al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e il dipendente aveva diritto a un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto e corrispondente al periodo intercorrente dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione. Da tale indennità andava dedotto quanto il lavoratore avesse eventualmente percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative (c.d. aliunde perceptum), ma, in ogni caso, l’indennità non poteva essere inferiore a 5 mensilità. Inoltre, in alternativa alla reintegrazione, e fermo restando il diritto a ottenere il risarcimento del danno, il lavoratore poteva chiedere (e tutt’ora può in caso di condanna alla reintegra) al datore di lavoro – con richiesta da effettuarsi entro 30 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia o dall’invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore – un’indennità pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto .
Il nuovo testo dell’articolo 18, St. Lav., invece, prevede ben 4 diverse declinazioni di tutele, che variano a seconda del vizio accertato:
- secondo i primi 3 commi, ovvero nei casi in cui il licenziamento sia discriminatorio, ritorsivo, intimato in forma orale o comunque intimato nei casi di nullità previsti dalla legge (ad esempio in concomitanza con il matrimonio, in violazione dei divieti di licenziamento di cui all’articolo 54, commi 1, 6, 7 e 9, T.U. maternità, etc.) o determinato da motivo illecito determinante, il giudice applica la “vecchia” tutela reale piena;
- secondo quanto previsto al comma 4, invece, quando non ricorrono gli estremi del giustificato motivo o della giusta causa per insussistenza del fatto posto a base del licenziamento (la Corte Costituzionale ha di recente abrogato l’aggettivo “manifesta” insussistenza), il giudice applica la c.d. tutela reale attenuata: e, dunque, condanna il datore di lavoro a reintegrare il dipendente nel posto di lavoro e al pagamento di un indennizzo commisurato alla retribuzione con il limite però di 12 mensilità (e non di tutte quelle medio tempore maturate come era in precedenza, che – vista la durata media del processo – spesso travalicavano l’anno retributivo), oltre al versamento dei contributi previdenziali per tutto il periodo dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione;
- ai sensi del comma 5, nelle altre ipotesi in cui si accerti che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo addotto dal datore di lavoro, il giudice applica la c.d. tutela obbligatoria forte e, quindi, condanna il datore al pagamento di un’indennità risarcitoria in una misura compresa fra 12 e 24 mensilità della retribuzione globale di fatto, tenendo conto dell’anzianità del lavoratore, del numero dei dipendenti, della dimensione dell’attività economica e del comportamento e condizioni delle parti;
- ai sensi del comma 6, nell’ipotesi di vizi formali, si applica la c.d. tutela obbligatoria ridotta: il giudice pertanto dichiara l’inefficacia del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità variabile tra 6 e 12 mensilità della retribuzione globale di fatto, da valutarsi da parte del giudice in relazione alla gravità della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro;
- infine, il comma 7 prevede che “Il giudice applica la medesima disciplina di cui al quarto comma del presente articolo nell’ipotesi in cui accerti il difetto di giustificazione del licenziamento intimato, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, L. 68/1999, per motivo oggettivo consistente nell’inidoneità fisica o psichica del lavoratore, ovvero che il licenziamento è stato intimato in violazione dell’articolo 2110, secondo comma, del codice civile”.
Il nuovo sistema, quindi, vede(va) un chiaro abbandono di quello che era il regime di job property, ora solo residuale, in favore di quello basato, invece, sulla liability rule (per la verità, occorre segnalare che la Corte Costituzionale ha più volte smantellato il sistema, sancendo di fatto un ritorno alla vecchia disciplina).
Com’è evidente, dunque, l’articolo 18, comma 7, St. Lav., tipizza specificatamente l’ipotesi della violazione dell’articolo 2110, cod. civ., invocata dalla lavoratrice nel caso di specie. Secondo il medesimo articolo, però: “Le disposizioni dei commi dal quarto al settimo si applicano al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici lavoratori o più di cinque se si tratta di imprenditore agricolo, nonché al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che nell’ambito dello stesso comune occupa più di quindici dipendenti e all’impresa agricola che nel medesimo ambito territoriale occupa più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa più di sessanta dipendenti”.
Nulla quaestio, dunque, nel caso di imprese c.d. grandi, in caso di violazione dell’articolo 2110, cod. civ., si applicherà il comma 7, che, a sua volta, in punto di conseguenze sanzionatorie, rimanda al comma 4 e, quindi, all’applicazione della c.d. tutela reintegratoria debole.
Ma cosa accade, invece, per le piccole aziende?
Il comma 7, infatti, visto quanto disciplinato dal seguente comma 8, non troverebbe applicazione se non per le aziende con più di 15 dipendenti e, in generale, salvo il comma 1, la disciplina dell’articolo 18, St. Lav., trova applicazione, dunque, solo per le grandi imprese.
Per le aziende sotto i 15 dipendenti, infatti, la disciplina delle tutele del licenziamento è prevista dalla L. 604/1966.
Dunque, per quanto concerne i lavoratori delle piccole imprese assunti prima del 7 marzo 2015, data di entrata in vigore del D.Lgs. 23/2015 (le c.d. tutele crescenti), la legge prevede, anzitutto, che essi possano beneficiare della tutela reintegratoria nei seguenti casi:
- licenziamento nullo perché discriminatorio;
- licenziamento intimato in concomitanza con il matrimonio;
- licenziamento comminato in violazione delle disposizioni in materia di tutela della maternità e paternità;
- licenziamento determinato da motivo illecito determinante;
- altre ipotesi di licenziamento nullo previsto dalla legge;
- licenziamento inefficace perché intimato in forma orale.
In tutte le altre ipotesi di licenziamento illegittimo, invece, il lavoratore avrà diritto a una tutela esclusivamente economica.
In particolare, l’articolo 8, L. 604/1966, nella sua attuale formulazione, prevede che quando il giudice accerta che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro è tenuto a riassumere il lavoratore entro il termine di 3 giorni o, in mancanza, a versargli un’indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 e un massimo di 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
La motivazione della sentenza
Ebbene, visto il quadro normativo, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 27334/2022, ha quindi accolto il ricorso della lavoratrice, condannando la società alla reintegra di quest’ultima e al risarcimento del danno entro le 12 mensilità, come previsto dall’articolo 18, comma 4, St. Lav..
In particolare, la lavoratrice ha, infatti, lamentato, richiamando la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 12568/2018, che il licenziamento intimato in violazione dell’articolo 2110, cod. civ., costituisca ipotesi del tutto autonoma, e che l’articolo 18, comma 7, St. Lav., là dove richiama l’articolo 2110, cod. civ., debba essere letto in stretta correlazione col comma 1, a cui è legato da un rapporto tra species e genus, e non in relazione al comma 8 del medesimo articolo 18, St. Lav.. Secondo la ricorrente, infatti, tale conclusione costituirebbe logico corollario della radicale nullità del licenziamento intimato nonostante il mancato superamento del periodo di comporto, a cui non può che conseguire il rimedio della reintegra a prescindere dal requisito dimensionale, per il livello di disvalore riconosciuto dall’ordinamento in relazione alla tutela del diritto alla salute, di cui all’articolo 32, Costituzione, e del diritto al lavoro, di cui agli articoli 1, 4 e 35, Costituzione.
Secondo la Corte di Cassazione costituisce punto fermo nella giurisprudenza quello secondo cui “il licenziamento intimato per il perdurare delle assenze per malattia od infortunio del lavoratore, ma prima del superamento del periodo massimo di comporto fissato dalla contrattazione collettiva o, in difetto, dagli usi o secondo equità, è nullo per violazione della norma imperativa di cui all’articolo 2110, comma 2, cod. civ.” (così Cassazione SS.UU. n. 12568/2018).
Nell’articolo 2110, comma 2, cod. civ., dunque, si rinviene un’astratta predeterminazione (legislativo-contrattuale) del punto di equilibrio fra l’interesse del lavoratore a disporre di un congruo periodo di assenze per ristabilirsi a seguito di malattia o infortunio e quello del datore di lavoro di non doversi fare carico a tempo indefinito del contraccolpo che tali assenze cagionano all’organizzazione aziendale.
Secondo la Corte, dopo aver ripercorso un lungo percorso giurisprudenziale anche costituzionale “In relazione ai rapporti di lavoro assistiti dalla tutela c.d. obbligatoria, di cui all’articolo 8, legge 604 del 1966, questa Corte, con orientamento costante, ha osservato come gli effetti del licenziamento dichiarato nullo (v. Cass. n. 15093 del 2009: licenziamento nullo per illiceità del motivo; Cass. n. 18537 del 2004; Cass. n. 9549 del 1995: licenziamento nullo perché intimato in violazione dell’articolo 2, comma 2, della legge n. 1204 del 1971; Cass. n. 2856 del 1979: licenziamento per rappresaglia, ante disciplina dell’articolo 3 della legge nr. 108 del 1990;) non fossero disciplinati, in via di estensione analogica, dalla normativa dettata dall’articolo 8 della legge 604 del 1966, recando quest’ultima esclusivamente la disciplina per la diversa ipotesi dell’annullamento del licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo, bensì secondo il regime delle nullità di diritto comune di cui all’articolo 1418 cod. civ. (v. da ultimo Cass. n. 19661 del 2019 cit.)” e che “come la dottrina ha rilevato, con la riscrittura dell’articolo 18 St. lav. ad opera della legge n. 92 del 2012, le ipotesi precedentemente assoggettate al regime delle nullità di diritto comune sono state ricondotte nella previsione dell’articolo 18, comma 1, in forza della clausola che dispone l’applicazione della tutela reale piena, oltre che nelle fattispecie tipizzate dalla norma, anche negli “altri casi di nullità previsti dalla legge” e “quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro””.
Secondo la Suprema Corte, infatti, non sarebbe applicabile l’articolo 8, L. 604/1966, poiché disciplinante i soli casi di illegittimità del licenziamento e non già quelli di nullità e, dunque, il licenziamento nullo per violazione dell’articolo 2110, cod. civ., non rientrerebbe nella tutela obbligatoria ivi prevista.
D’altro canto, argomenta la Corte di legittimità, non si potrebbe neppure ricondurre tale nullità alla disciplina della nullità del diritto comune (o dell’articolo 18, comma 1, St. Lav.), poiché comporterebbe una tutela più forte per i lavoratori di piccole imprese di quella garantita dall’articolo 18, commi 4 e7, St. Lav., che, per i lavoratori dipendenti da datori aventi i requisiti dimensionali, limita a 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto il risarcimento del danno.
Pertanto, secondo la Corte di Cassazione, il licenziamento in violazione dell’articolo 2110, cod. civ., pur rientrando tra gli “altri casi di nullità previsti dalla legge” di cui al comma 1, è inserito nel comma 7 soltanto quod poenam, al fine, cioè, dell’applicazione del rimedio meno rigoroso quale è la tutela reintegratoria attenuata che, dunque, andrà riconosciuta anche alle piccole imprese (altrimenti soggette a una disciplina ancora più “costosa”, il che sarebbe in conflitto con la ratio stessa dell’esclusione delle piccole imprese dall’applicazione tout court dell’articolo 18, St. Lav.).
Conclude la Cassazione, quindi, affermando il seguente principio di diritto: “Nel sistema delineato dall’articolo 18 della legge n. 300 del 1970, come modificato dalla legge n. 92 del 2012, il licenziamento intimato in violazione dell’articolo 2110, comma 2, cod. civ., è nullo e le sue conseguenze sono disciplinate, secondo un regime sanzionatorio speciale, dal comma 7, che a sua volta rinvia al comma 4, del medesimo articolo 18, quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro”.
La pronuncia, dunque, allarga ulteriormente le maglie di applicabilità della tutela reintegratoria (seppur attenuata), rendendo sempre più rischioso il calcolo, peraltro non spesso facile né scontato come nel caso di specie, vista la solo successiva imputazione delle assenze a responsabilità datoriale, del periodo di comporto.
Resta, invece, aperta la questione relativa ai contratti a tutele crescenti: nell’impianto del D.Lgs. 23/2015, infatti, non è prevista alcuna tutela reintegratoria attenuata e, pertanto, non sarà attuabile quello stesso contemperamento previsto dalla Cassazione nella sentenza in commento.
Quale sarà, dunque, la conseguenza sanzionatoria nel caso di un licenziamento per mancato superamento del comporto di un lavoratore assunto dopo il 7 marzo 2015 in una piccola azienda?
L’unica via sembrerebbe la nullità, ma una siffatta soluzione contrasterebbe con quello stesso ragionamento fatto proprio dalla Corte di Cassazione e si risolverebbe in una maggior tutela del lavoratore in questione rispetto a un altro assunto ante 2015 in una grande azienda. La soluzione, quindi, è ancora tutta da trovare.
Si segnala che l’articolo è tratto da “Il giurista del lavoro“.
Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia: