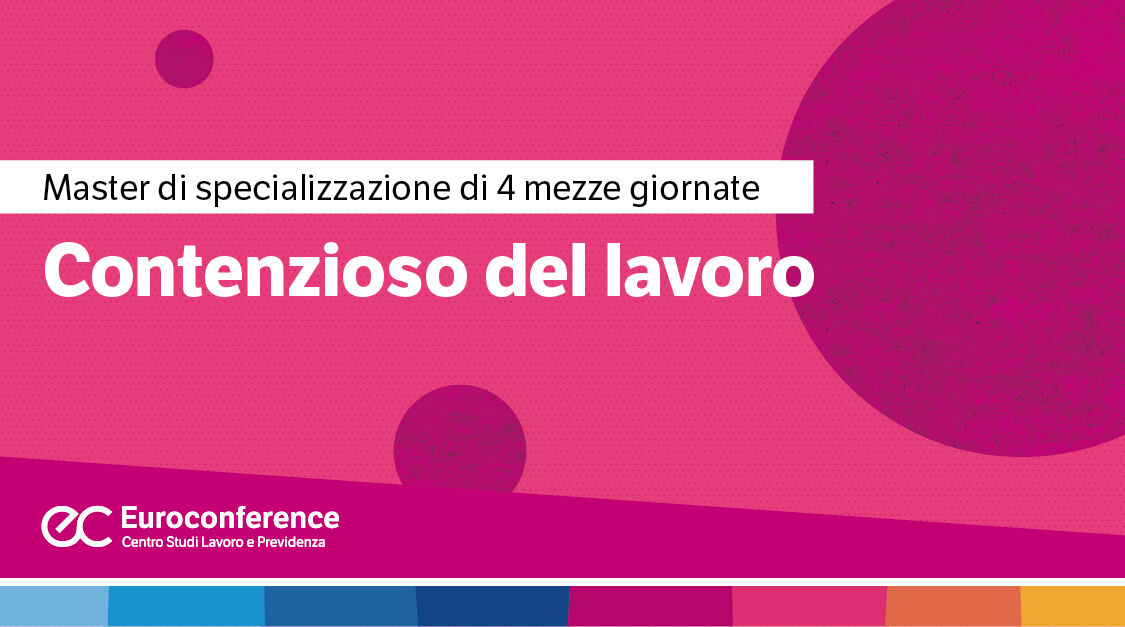I divieti di discriminazione in fase preassuntiva
di Sergio PasseriniSofia Bitella
Con provvedimento dello scorso 23 marzo 2022, il Tribunale di Roma si è pronunciato sulla natura discriminatoria della mancata assunzione e dell’esclusione dai processi di reclutamento di lavoratrici a causa della loro condizione di gravidanza. Partendo da tale spunto di riflessione, l’articolo analizza i divieti di discriminazione operanti nella selezione dei lavoratori in fase preassuntiva, divieti in forza dei quali il datore di lavoro non può indagare alcun aspetto della vita privata dei candidati e neppure porre a fondamento della selezione criteri che siano direttamente o indirettamente discriminatori e privi di attinenza alle mansioni contrattuali.
I fatti oggetto del giudizio innanzi al Tribunale di Roma
In un recente caso affrontato dal giudice del lavoro del Tribunale di Roma, 2 lavoratrici avevano presentato la loro candidatura alle selezioni di personale da assumere in una nota società del trasporto aereo da poco costituita. La loro candidatura, tuttavia, non era stata presa in considerazione dalla società, che non le aveva neppure chiamate a partecipare alla selezione e ai primi colloqui.
Le 2 candidate hanno lamentato di essere state escluse dalle selezioni poiché in gravidanza e hanno sostenuto che la società avesse tenuto la medesima condotta anche nei confronti di tutte le altre candidate lavoratrici in stato di gravidanza o in astensione obbligatoria per maternità, indicando i nominativi di almeno altre 6 lavoratrici escluse dal processo di recruiting per la stessa ragione. Le candidate hanno, inoltre, affermato l’opacità dei criteri di scelta seguiti nella selezione del personale, essendo stati selezionati candidati con esperienza e anzianità minori rispetto alle loro.
Per tali ragioni, le lavoratrici hanno promosso innanzi al Tribunale competente un ricorso ai sensi dell’articolo 38, D.Lgs. 198/2006, chiedendo al giudice del lavoro di accertare e dichiarare il carattere discriminatorio della condotta tenuta dalla società, consistita nell’aver omesso di ammetterle alla selezione e, conseguentemente, di assumerle in ragione del loro stato di gravidanza. Le lavoratrici hanno chiesto al giudice di emettere ogni idoneo provvedimento diretto a rimuovere completamente gli effetti della condotta discriminatoria, di ordinare alla società di assumerle e di condannare la medesima società al risarcimento dei danni da loro patiti a causa del comportamento discriminatorio subito e per la conseguente perdita di chance.
La società si è difesa rilevando, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per insussistenza di alcuna discriminazione: in particolare, ha evidenziato come il piano per la selezione del personale fosse all’epoca dei fatti ancora in corso e destinato a concludersi solo nel 2025; solo quando il processo di selezione fosse stato completamente terminato si sarebbe pertanto potuto indagare se la selezione fosse stata davvero condotta con criteri discriminatori.
La società, inoltre, ha sostenuto di non essere – in quanto in fase di start-up – tenuta al rispetto di alcun criterio selettivo specifico, se non quelli espressamente concordati con le organizzazioni sindacali (ovvero l’esclusione dalla selezione dei candidati destinati a maturare i requisiti pensionistici durante lo svolgimento del piano di assunzioni e dei candidati privi delle necessarie certificazioni, quali il green pass e il recurrent training, abilitazione necessaria per operare a bordo come membro di equipaggio di cabina). La società ha affermato, in particolare, che le lavoratrici erano state scartate dalle selezioni solo in quanto, al momento della presentazione delle candidature, avevano entrambe il recurrent training in scadenza e ha aggiunto che, in ragione del termine della gravidanza, esse non avrebbero potuto rientrare in servizio prima dell’estate 2022. La società ha sottolineato, poi, che nessuna discriminazione poteva essere rinvenuta nella condotta tenuta, in quanto, al momento delle selezioni del personale, essa era totalmente ignara dello stato di gravidanza delle 2 lavoratrici; a riprova di ciò veniva anche dedotto come fosse stata, invece, assunta una lavoratrice in congedo di maternità e talune lavoratrici madri di un bambino di età inferiore a 12 mesi. Da ultimo, la società ha contestato che le lavoratrici avessero soddisfatto i loro oneri di prova, in quanto non avrebbero fornito elementi di fatto, neppure di carattere statistico, che potessero essere ritenuti idonei a confermare l’esistenza di condotte discriminatorie poste in essere dalla società.
Il Tribunale di Roma, con decreto del 23 marzo 2022, ha, invece, parzialmente accolto il ricorso delle 2 candidate lavoratrici e ha accertato la discriminatorietà della condotta tenuta nei loro confronti dalla società, condannando quest’ultima a risarcire il danno da perdita di chance da loro subito.
Sintesi del quadro normativo: divieti di discriminazione nell’accesso al lavoro
Non vi è dubbio che il principio di non discriminazione permei il nostro ordinamento e, conseguentemente, la disciplina giuslavoristica sin dalle fondamenta. L’articolo 3, Costituzione, in particolare, sancisce il principio cardine dell’uguaglianza sia formale sia sostanziale e il successivo articolo 37 ribadisce che alle lavoratrici debbano essere riconosciuti i medesimi diritti dei colleghi uomini.
Tali principi di carattere precettivo e programmatico trovano, poi, ampia concretizzazione nella disciplina giuslavoristica: i poteri di indagine e di controllo del datore di lavoro sui lavoratori trovano, infatti, un chiaro limite nel diritto dei lavoratori medesimi al rispetto della loro libertà di pensiero e di espressione, al rispetto della loro riservatezza e della loro dignità personale.
Per quanto riguarda, in particolare, gli accertamenti preassuntivi, l’articolo 8, L. 300/1970, prevede espressamente che “è fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell’assunzione” – così come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro – “di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale del lavoratore”. Sempre lo Statuto dei Lavoratori, all’articolo 5, vieta al datore di lavoro di condurre direttamente indagini sullo stato di salute dei lavoratori.
Anche l’articolo 3, D.Lgs. 216/2003 – in attuazione della Direttiva 2000/78/CE sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – precisa che il principio di parità di trattamento – in riferimento a religione, convinzioni personali, handicap, età e orientamento sessuale – si applica anche all’“accesso all’occupazione e al lavoro, sia autonomo che dipendente, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione”.
In particolare, con riguardo ai procedimenti di ricerca e selezione del personale per conto di soggetti terzi, l’articolo 10, D.Lgs. 276/2003, introduce un divieto di indagare o, in ogni caso, di svolgere le selezioni del personale “in base alle convinzioni personali, alla affiliazione sindacale o politica, al credo religioso, al sesso, all’orientamento sessuale, allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, alla età, all’handicap, alla razza, all’origine etnica, al colore, alla ascendenza, all’origine nazionale, al gruppo linguistico, allo stato di salute nonché ad eventuali controversie con i precedenti datori di lavoro, a meno che non si tratti di caratteristiche che incidono sulle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa o che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell’attività lavorativa”.
La norma pone, altresì, un generale divieto di trattare dati personali dei lavoratori che non siano assolutamente pertinenti alle loro attitudini professionali e al loro inserimento lavorativo.
L’ordinamento italiano ha dedicato alla parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini il Codice delle pari opportunità (D.Lgs. 198/2006). Di assoluta rilevanza è l’articolo 25 di tale Codice, che vieta, con attenzione alla fase di selezione del personale, qualsiasi atto o comportamento che possa produrre un effetto pregiudizievole discriminando le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso; la norma qualifica espressamente quale “discriminazione diretta” qualsiasi disposizione, criterio, prassi, atto, patto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando le candidate e i candidati, in fase di selezione del personale, in ragione del loro sesso. La norma, inoltre, a rafforzamento della tutela antidiscriminatoria, precisa, altresì, che sono vietate le forme di c.d. discriminazione indiretta, discriminazione che si realizza quando “una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento, compresi quelli di natura organizzativa o incidenti sull’orario di lavoro, apparentemente neutri mettono o possono mettere i candidati in fase di selezione e i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto a lavoratori dell’altro sesso, salvo che riguardino requisiti essenziali allo svolgimento dell’attività lavorativa, purché l’obiettivo sia legittimo e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari”.
E ancora, con particolare riferimento alla fase di accesso al lavoro, l’articolo 27, commi 1 e 2, Codice delle pari opportunità, precisa che “È vietata qualsiasi discriminazione per quanto riguarda l’accesso al lavoro, in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione […]. La discriminazione di cui al comma 1 è vietata anche se attuata: a) attraverso il riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, nonché di maternità o paternità, anche adottive; in modo indiretto, attraverso meccanismi di preselezione ovvero a mezzo stampa o con qualsiasi altra forma pubblicitaria che indichi come requisito professionale l’appartenenza all’uno o all’altro sesso”.
Il datore di lavoro, come emerge dalla normativa sintetizzata, non può, nella ricerca del proprio personale, indagare alcun aspetto della vita privata dei candidati e neppure porre a fondamento del procedimento di selezione dei criteri che siano direttamente o indirettamente discriminatori, dando rilevanza a fatti, elementi o opinioni privi di attinenza alle mansioni che intenda affidare alle lavoratrici o ai lavoratori da assumere.
Risultano, quindi, vietate tutte le forme di discriminazione: non solo la discriminazione diretta, nella quale un soggetto è trattato meno favorevolmente di quanto sia trattata un’altra persona in una situazione analoga, ma anche la discriminazione indiretta, nella quale un criterio apparentemente neutro conduce a una situazione di svantaggio di talune persone rispetto ad altre, in considerazione di alcune loro caratteristiche (come il sesso) che l’ordinamento intende proteggere dalla discriminazione.
È stato, peraltro, ampiamente ribadito anche dalla giurisprudenza comunitaria che è idonea a integrare una discriminazione diretta anche una condotta che, anche solo sul piano astratto, impedisca o renda maggiormente difficoltoso l’accesso all’occupazione (Corte di Giustizia, causa C-81/12; Corte di Giustizia, causa C-54/07).
La sentenza del Tribunale di Roma: tutela contro la discriminazione anche in fase preassuntiva
La sentenza in commento ribadisce che il datore di lavoro, nella selezione del personale, non è libero di scegliere in modo totalmente arbitrario i criteri di selezione del personale, poiché sussistono nel nostro ordinamento dei vincoli di natura legale a cui egli è tenuto ad attenersi anche nella selezione del personale: fra questi, vi è senza dubbio la normativa in materia antidiscriminatoria.
Tutto il ragionamento sviluppato nel provvedimento del Tribunale di Roma prende le mosse da una rilevante premessa: la tutela antidiscriminatoria opera in ogni fase del rapporto di lavoro, compresa, dunque, la fase preassuntiva.
A supporto di tale assunto, il giudice richiama sia il disposto legislativo dell’articolo 27, commi 1 e 2, lettera a), D.Lgs. 198/2006 – che, come anticipato, vieta ogni forma di discriminazione nell’accesso al lavoro anche se attuata in riferimento allo stato di gravidanza – sia le numerose pronunce della Corte di Giustizia, la quale ha più volte precisato come i divieti di discriminazione operino anche nella fase antecedente alla costituzione di un rapporto di lavoro. La consolidata giurisprudenza comunitaria ha, infatti, ampiamente chiarito come i divieti di discriminazione trovino necessaria applicazione, in considerazione della rilevanza che l’accesso al lavoro riveste nella vita personale, anche nella fase preassuntiva (sul punto, Corte di Giustizia Europea, causa C-188/15).
In riferimento alla discriminazione attuata in ragione dello stato di gravidanza, viene, inoltre, richiamata una nota sentenza di alcuni anni fa della Corte di Giustizia, la sentenza 8 novembre 1990 resa nella causa C-177/88, la quale aveva statuito che “un rifiuto d’assunzione per motivo di gravidanza può opporsi solo alle donne e rappresenta quindi una discriminazione diretta a motivo del sesso. Orbene, un rifiuto di assunzione dovuto alle conseguenze finanziarie di un’assenza per causa di gravidanza deve esser considerato fondato essenzialmente sull’elemento della gravidanza. Siffatta discriminazione non può giustificarsi con il danno finanziario subito dal datore di lavoro, in caso di assunzione di una donna incinta, durante tutto il periodo d’assenza per maternità” (nella medesima direzione si è poi pronunciata la sentenza CGUE del 3 febbraio 2000, causa C-207/98, Silke-Karin Mahlburg contro Land Mecklenburg-Vorpommern).
In sintesi, dunque, il Tribunale, dopo aver confermato che la tutela antidiscriminatoria opera anche nella fase antecedente all’instaurazione del rapporto di lavoro, ovverosia nella fase di ricerca e selezione del personale, ribadisce, altresì, che nessun trattamento sfavorevole può essere messo in atto in considerazione dello stato di gravidanza di una candidata, non potendo certo la mancata assunzione trovare alcuna giustificazione in relazione al danno finanziario a carico del datore di lavoro in caso di assunzione di una donna incinta.
Segue: la ripartizione dell’onere probatorio circa la sussistenza della condotta discriminatoria
In punto di onere probatorio, il giudice di Roma evidenzia come nei giudizi in materia di discriminazione di genere trovi applicazione l’articolo 40, D.Lgs. 198/2006, il quale prevede un regime di distribuzione dell’onere della prova a vantaggio del soggetto che ricorra in giudizio avverso una condotta discriminatoria: quando il soggetto che si affermi discriminato presenti elementi di fatto (anche di carattere statistico) che facciano presumere, in termini precisi e concordanti, la sussistenza di atti e comportamenti discriminatori, spetterà alla controparte dimostrare che non vi è stata alcuna discriminazione nei comportamenti lamentati.
Come ampiamente ribadito dalla giurisprudenza, tale principio non costituisce un’inversione dell’onere della prova, ma solo una attenuazione del regime probatorio ordinario[1].
Nel caso di specie, il giudice ha ritenuto che le lavoratrici avessero presentato elementi precisi e concordanti circa l’esistenza di una condotta discriminatoria in ragione della loro gravidanza e che la società che stava effettuando la selezione non fosse stata, invece, in grado di portare elementi che dimostrassero l’assenza di una discriminazione.
Il Tribunale ha ribadito, inoltre, il carattere oggettivo della condotta discriminatoria vietata: affinché una condotta possa essere considerata discriminatoria non è necessario che il comportamento sia posto in essere con specifici intenti discriminatori, ma è sufficiente che la condotta produca oggettivamente un effetto discriminatorio, anche indipendentemente dalla volontà del suo autore; se fosse richiesta anche la prova dell’elemento soggettivo, si provocherebbe, secondo il Tribunale, “un aggravamento dell’onere di portata tale da rendere la tutela ben difficilmente azionabile”[2].
Inoltre, il Tribunale si è conformato al consolidato principio di “vicinanza della prova”, in base al quale l’onere della prova dev’essere ripartito tenendo conto della concreta possibilità che le parti hanno di provare circostanze afferenti alla sfera d’azione dell’altra parte. Dunque, essendo ragionevole far ricadere l’onere probatorio sulla parte a cui è più vicino il fatto da provare, avrebbe dovuto essere la società a indicare, per esempio, il nominativo di eventuali lavoratrici gestanti assunte mediante il procedimento di selezione, così da dimostrare l’assenza di una discriminazione vietata.
Nel decreto in esame, è di particolare interesse come il Tribunale abbia utilizzato, in applicazione dei poteri istruttori particolarmente ampi del giudice del lavoro, anche dei dati di natura statistica circa il rapporto tra popolazione femminile in età fertile e numero delle nascite a livello nazionale: presi in considerazione i dati statistici che indicano una nascita ogni 30 donne in età fertile, la selezione – che ha condotto all’assunzione di 412 donne – avrebbe dovuto condurre all’assunzione di indicativamente il 3% di donne in stato di gravidanza e, dunque, ricalibrando il numero in ragione della presenza di donne non più in età fertile e della durata del processo di selezione, di 6/7 donne in gravidanza; assunzione che la società non era stata in grado di dimostrare.
Alcuni precedenti giurisprudenziali in materia di discriminazione nell’accesso al lavoro
Questo provvedimento del Tribunale di Roma è solo una delle più recenti pronunce in tema di discriminazioni nella fase di accesso al lavoro e all’occupazione. Infatti, come anticipato, il datore di lavoro non può, nella ricerca di lavoratori, indagare alcun aspetto della vita privata dei candidati e neppure porre a fondamento del procedimento di selezione dei criteri che siano direttamente o indirettamente discriminatori.
Al datore di lavoro o a chi svolga attività di selezione e ricerca del personale è vietato utilizzare come criteri di scelta nella selezione elementi che possano configurarsi come discriminatori in ragione di uno dei fattori di discriminazione vietati dall’ordinamento (convinzioni personali, politiche, sindacali, religiose, sesso e orientamento sessuale, origine etnica, etc.). La giurisprudenza ha, quindi, escluso la liceità di indagini preassuntive e di criteri di selezione inerenti ad aspetti della vita privata del lavoratore e a fatti privi di attinenza alle mansioni per le quali il lavoratore deve essere assunto.
La rilevanza della discriminatorietà anche delle condotte attuate in fase preassuntiva risulta da tempo consolidata; la giurisprudenza ha ampiamente chiarito che integra gli estremi della violazione dell’articolo 8, L. 300/1970, la raccolta, attraverso colloqui selettivi e accertamenti affidati anche ad agenzie private d’investigazione, di notizie relative alle caratteristiche morali, psicologiche e comportamentali dei singoli lavoratori da assumere. Tale norma dev’essere interpretata nel senso di consentire all’imprenditore di verificare esclusivamente informazioni riguardanti le attitudini professionali dei potenziali dipendenti, quali il possesso dei requisiti tecnici (preparazione, esperienza, abilità) necessari ad assolvere le mansioni cui saranno adibiti[3].
È controverso se la richiesta del certificato penale o del certificato dei carichi pendenti possa essere giustificata facendo riferimento all’articolo 8, St. Lav., quale accertamento di “fatti rilevanti ai fini dell’attitudine professionale del lavoratore”. In alcuni casi, la richiesta è imposta da normative di settore (si pensi alla richiesta obbligatoria di certificato del casellario giudiziale per chi “intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, imposta dall’art. 2 del D. Lgs. 39/2014”). Laddove non imposta da una normativa specifica, la richiesta pare difficile da giustificare solo in base all’articolo 8, St. Lav., anche per ragioni di protezione dei dati personali (si veda anche l’articolo 2-octies, D.Lgs. 196/2003, il Codice in materia di protezione dei dati personali). Controversa la facoltà di richiedere il certificato dei carichi pendenti: parte della giurisprudenza ritiene che ciò sia illecito, in quanto confliggente con il principio costituzionale della presunzione di innocenza (Cassazione n. 19012/2018); altri arresti giurisprudenziali hanno invece valorizzato il principio costituzionale di libertà di iniziativa economica, che consentirebbe al datore di lavoro di effettuare una libera valutazione sull’idoneità del candidato, anche attraverso l’acquisizione del certificato dei carichi pendenti (Cassazione n. 17167/2020).
Il Tribunale di Torino ha ritenuto discriminatoria la mancata assunzione di una lavoratrice che, come era stato dedotto dalla stessa, il datore di lavoro aveva escluso poiché musulmana ed extracomunitaria. A tal fine, il giudice aveva valorizzato gli elementi presuntivi dedotti dalla lavoratrice stessa, quali lo scarsissimo numero di lavoratori extracomunitari assunti dal datore di lavoro e le dichiarazioni dello stesso, il quale aveva affermato “magari come musulmana hai delle particolarità tipo quando c’è il ramadan non puoi lavorare alle otto di sera” e “l’importante è che ci sia la cittadinanza italiana” (Tribunale di Torino, 28 dicembre 2016).
Sono state ritenute discriminatorie, in una nota pronuncia, le dichiarazioni rese nel corso di una trasmissione radiofonica da un avvocato, il quale manifestava la propria volontà di non assumere nel proprio studio persone omosessuali, in quanto tali affermazioni erano volte a scoraggiare taluni soggetti dal presentare le proprie candidature, integrando una limitazione delle condizioni di accesso all’occupazione e al lavoro (Tribunale di Bergamo, 6 agosto 2014).
Analoga posizione, in una vicenda di discriminazione razziale, era stata assunta anche dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nella sentenza del 10 luglio 2008 resa nella causa C-54/07; la Corte di Giustizia ha ritenuto che “il fatto che un datore di lavoro dichiari pubblicamente che non assumerà lavoratori dipendenti aventi una determinata origine etnica o razziale configura una discriminazione diretta nell’assunzione ai sensi dell’art. 2, n. 2, lett. a), della direttiva 2000/43, in quanto siffatte dichiarazioni sono idonee a dissuadere fortemente determinati candidati dal presentare le proprie candidature e, quindi, a ostacolarne l’accesso al mercato del lavoro”.
In riferimento all’adozione di criteri discriminatori, è stata ravvisata violazione dei divieti antidiscriminatori nella vicenda di una P.A., la quale, dopo aver bandito tra i dipendenti una selezione per progressione orizzontale, aveva previsto quale unico modo di accedere alla procedura le modalità informatiche, con ciò rendendo impossibile la trasmissione della domanda da parte di un lavoratore non vedente[4].
L’esclusione di una candidata da una selezione per un posto di lavoro con mansioni di hostess di fiera, determinato dal rifiuto della candidata stessa di togliere l’hijab, è stato valutato dalla Corte d’Appello di Milano come discriminazione diretta in ragione dello stretto collegamento tra questo abbigliamento e la sfera religiosa, in quanto, nel caso specifico, non si poteva ritenere che il capo scoperto costituisse requisito essenziale della prestazione, dal momento che tale requisito neppure era stato indicato dalla società datrice di lavoro tra i criteri selettivi[5].
La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto affette da nullità clausole di un bando di concorso per il reclutamento di nuovo personale da parte di enti pubblici che subordinavano l’assunzione dei vincitori all’esistenza o, al contrario, all’inesistenza di vincoli di parentela con dipendenti dell’ente, trattandosi di fatti estranei alla professionalità dei lavoratori da assumere[6].
Non è stata, invece, rinvenuta una discriminazione per handicap nella mancata assunzione di un soggetto privo dei requisiti fisici di acutezza visiva richiesti dal datore di lavoro, in mancanza dell’allegazione e prova, da parte del candidato, di fatti idonei a fondare la presunzione che tali requisiti fossero eccessivi, anacronistici o sproporzionati[7].
Gli esempi potrebbero continuare, e a volte raggiungono livelli significativi di complessità e opinabilità; è capitato, per esempio, di recente che sia stata ritenuta una discriminazione fondata sulle convinzioni personali la previsione di un bando che condizionava una nuova assunzione alla sottoscrizione di un verbale di conciliazione con il quale venisse definita ogni potenziale controversia relativa a precedenti rapporti di lavoro con lo stesso datore di lavoro[8].
Come si vede, le questioni potenziali sono davvero numerose e straordinariamente complesse; il principale criterio di orientamento resta ancora oggi, a oltre 50 anni dalla sua pubblicazione, la regola contenuta nel più volte ricordato articolo 8, St. Lav., e, dunque, l’effettiva e dimostrabile rilevanza “ai fini della valutazione dell’attitudine professionale del lavoratore” del criterio di selezione adottato.
Di ciò occorrerà tenere conto anche nella gestione dei sempre più comuni e diffusi strumenti di intelligenza artificiale utilizzati nella selezione del personale: non è infrequente che determinati “pregiudizi” vengano incorporati nell’algoritmo utilizzato (l’algoritmo di recruiting, come spesso definito) e si traducano in scelte apparentemente oggettive, ma di fatto discriminatorie. Proprio perché – come abbiamo prima evidenziato – il divieto di discriminazione opera su basi oggettive, anche indipendentemente, cioè, da una consapevole volontà discriminatoria dell’autore della condotta, è fondamentale che chi utilizza nella selezione del personale programmi di intelligenza artificiale sia ben consapevole dei loro criteri di funzionamento, così da evitare di restare a propria volta “vittima” delle conseguenze di pregiudizi più o meno consapevolmente nascosti nelle pieghe di funzionamento dell’algoritmo.
[1] Ex multis, Cassazione n. 14206/2013.
[2] Nella medesima direzione anche Cassazione n. 6575/2016.
[3] Già sul punto Cassazione 27 febbraio 1981.
[4] Tribunale di Napoli, 31 maggio 2012.
[5] Corte d’Appello di Milano, n. 579/2016.
[6] Cassazione n. 3831/2012; Cassazione n. 570/2002; Cassazione n. 2430/1991.
[7] Tribunale di Milano, 27 giugno 2016.
[8] Corte d’Appello di Napoli, n. 3883/2021 del 3 gennaio 2022.
Si segnala che l’articolo è tratto da “Il giurista del lavoro“.
Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia: