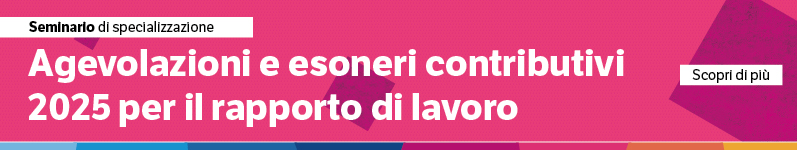Contrattazione integrativa in tema di rapporto a termine: l’esempio della Regione Lazio
di Michele Donati Scarica in PDF
Nel corso del presente contributo sarà analizzato il protocollo di intesa siglato nella Regione Lazio in vista del periodo del Giubileo e finalizzato alla gestione dei rapporti a tempo determinato, con particolare riferimento alle possibilità di deroga in materia di rapporto a tempo determinato. Sarà poi effettuato un parallelismo con altri contratti di secondo livello in passato previsti, in questo caso per quanto attiene alla definizione di ipotesi di stagionalità, al fine di analizzarne analogie e differenze.
La contrattazione territoriale integrativa prevista dalla Regione Lazio per il Giubileo
Nel rispetto degli spazi negoziali concessi dalle fonti normative e dalla contrattazione collettiva nazionale, è stato previsto per la Regione Lazio in generale, e per la Provincia di Roma in particolare, un protocollo di intesa avente la finalità di gestire al meglio i rapporti di lavoro in occasione del periodo del Giubileo.
Il contratto collettivo territoriale in questione presenta tratti assai accattivanti, a partire dalla platea dei datori di lavoro – e quindi dei rapporti – interessati.
La sigla datoriale firmataria è Confcommercio, che in virtù del proprio bacino di utenza, ha previsto la sottoscrizione di 2 differenti accordi, uno per il comparto del Terziario e uno parallelo per quello del Turismo.
Così facendo, è stato possibile anzitutto andare ad abbracciare tutte le realtà – siano esse esercenti attività di vendita, ovvero di pubblico esercizio – a qualsiasi titolo aderenti a Confcommercio.
Tale scelta appare oculata in virtù della stretta interconnessione tra i 2 mondi, a fronte di un impianto normativo che presenta, invece, notevoli differenze, proprio in materia di deroghe in tema di rapporti atipici (con maggiore flessibilità appannaggio del settore Turismo e pubblici esercizi).
Altro aspetto decisamente interessante dell’accordo è dato dalla trasversalità delle materie trattate e, quindi, delle soluzioni prospettate; sarebbe, infatti, riduttivo fermarsi alle soluzioni connesse al mercato del lavoro e alle tipologie contrattuali.
Di seguito saranno passati in rassegna i punti salienti degli accordi in questione e saranno confrontati con contratti collettivi territoriali di altre zone, aventi questa volta finalità di gestione dei picchi di più intensa attività.
Il contratto collettivo territoriale per il comparto del Terziario
Sigle firmatarie dell’accordo in questione, lato datoriale, sono:
- ConfCommercio Lazio e ConfCommercio Lazio Sud;
- ConfCommercio Lazio Nord;
- ConfCommercio Roma.
Già da questa distinzione appare evidente la centralità dell’ubicazione geografica delle attività interessate, e in particolare di quelle che sono collocate nella Città di Roma (o comunque in tale Provincia).
Come già accennato in premessa, l’accordo contiene specifiche previsioni in materia di tempo determinato, ma anche opportune previsioni connesse ad altri istituti.
Come, ad esempio, la disciplina del lavoro in modalità agile, che viene posta quale incipit degli interventi e che costituisce uno strumento decisamente opportuno per tentare di contribuire a decongestionare il traffico, specie nella zona della Capitale; viene, quindi, ad aggiungersi tale obbiettivo oltre a quelli fisiologici della migliore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Sotto questo profilo, il contratto integrativo prevede l’opportunità di prevedere in seno alle aziende l’adozione di modalità organizzative fondate sulle prestazioni in modalità agile.
Si tratta, anche in questo caso, di uno stimolo che è scevro da ogni obbligo (e non potrebbe essere diversamente) e che va nella direzione di favorire tale modalità organizzativa nelle realtà e rispetto alle mansioni compatibili con il lavoro in modalità agile.
Il testo dell’accordo territoriale richiama opportunamente anche alle fattispecie di priorità nella collocazione in modalità agile rispetto a quei lavoratori e a quelle lavoratrici che presentano situazioni personali rientranti tra quelle che, grazie al D.Lgs. 105/2022, sono state oggetto di novella all’interno delle fonti normative di riferimento.
Si tratta in particolare dei lavoratori che sono anche:
- genitori di figli con età inferiore a 14 anni;
- lavoratrici e lavoratori in situazione di grave disabilità ovvero che assistono familiari in condizioni di grave disabilità;
- caregiver.
Un passaggio molto interessante è quello immediatamente successivo, che, invero con stile articolato, prevede un particolare regime orario in costanza di svolgimento di lavoro agile.
Viene, infatti, previsto che, in ipotesi di ricorso allo smart working nel corso del 2025 che preveda almeno 2 giornate di prestazione rese in modalità agile, per una delle suddette giornate (fermo restando l’orario previsto su base giornaliera e settimanale) la prestazione sarà assunta come composta da 4 ore, con conseguente assorbimento del tempo restante attraverso l’utilizzo di permessi maturati e non goduti.
Si tratta di un passaggio che – in sostanziale discontinuità con il passato – interviene anche riguardo alla durata della prestazione giornaliera in costanza di svolgimento della prestazione in modalità agile (tendenzialmente, infatti, nella bibliografia sin qui prevista in tema di lavoro agile, le previsioni riscontrabili parlavano al massimo di divieto di svolgimento di lavoro straordinario, se non al ricorrere di particolari fattispecie e comunque previa autorizzazione datoriale).
Venendo al tema del rapporto a tempo determinato, è opportuno sottolineare come, anzitutto, le deroghe previste dal protocollo di intesa per la Regione Lazio attinga non dalle deleghe che norma (D.Lgs. 81/2015) e Ccnl prevedono in tema di stagionalità, quanto a quelle che concernono il rapporto a tempo determinato.
Viene, infatti, richiamato l’articolo 19, comma 1, D.Lgs. 81/2015, come risultante a seguito della novella apportata dal D.L. 48/2023, che ha conferito una decisiva centralità al ruolo della contrattazione collettiva, e soprattutto agli articoli 71-bis e 73 (e non al 75, che delega la contrattazione territoriale la possibilità di definire fattispecie di stagionalità ai sensi dell’articolo 21, comma 2, D.Lgs. 81/2015) del Ccnl Terziario Confcommercio.
Viene, anzitutto, sancito un periodo entro il quale sarà ammesso prevedere rapporti a tempo determinato da ritenersi connessi allo svolgimento del Giubileo, nel periodo compreso tra il 16 dicembre 2024 e il 30 agosto 2026, e previa indicazione nel contratto individuale di apposita locuzione di ancoraggio con il protocollo di intesa specifico.
Viene poi esteso il limite di contingentamento dei rapporti a tempo determinato, che è così declinato:
- per le aziende che hanno alle proprie dipendenze fino a 15 dipendenti: 8 contratti (dei quali massimo 5 a tempo determinato diretto e 3 in somministrazione);
- per le aziende che hanno da 15 a 30 dipendenti: 13 contratti a tempo determinato (dei quali massimo 7 a tempo determinato diretto e 6 in somministrazione);
- per le aziende con più di 30 dipendenti, il 38% (di cui massimo il 30% di contratti a tempo determinato e massimo il 15% di contratti in somministrazione).
È necessario, rispetto a tali rapporti, inviare un’apposita comunicazione all’Ebit Lazio a mezzo pec, avente ad oggetto i contratti a termine (distinti tra quelli a tempo determinato “diretto” e quelli in somministrazione) contenente la puntuale indicazione dei contratti attivati, la loro durata, il livello di inquadramento e il monte ore settimanale.
Da ultimo, viene previsto un innalzamento delle percentuali di maggiorazione per il lavoro prestato nei giorni festivi, incremento che cuberà un 20%, facendo raggiungere la percentuale del 50% al lavoro straordinario domenicale e festivo svolto all’interno dell’arco temporale del Giubileo.
Tale previsione trova applicazione (così come quella riguardante il lavoro agile) nei confronti di tutti i lavoratori e le lavoratrici del comparto Terziario, indipendentemente dalla data di stipula del rapporto e della relativa tipologia.
Da ultimo, ma in maniera trasversale, è prevista una costante interlocuzione con le rappresentanze sindacali eventualmente presenti in azienda, al fine di armonizzare quanto previsto dall’accordo territoriale, rispetto a eventuali e paralleli contratti collettivi aziendali.
Il contratto collettivo territoriale per il comparto Turismo e Pubblici esercizi
L’accordo territoriale che riguarda il comparto del Turismo e dei pubblici esercizi sostanzialmente ricalca quello già visto per il Terziario, al netto di alcune differenze.
Partiamo dalle analogie, che riguardano anzitutto le previsioni in tema di lavoro agile.
Sono poi previsti dei passaggi tendenzialmente coerenti con l’accordo esaminato in precedenza, al netto delle differenze strutturali riscontrabili nella contrattazione collettiva, come ad esempio le estensioni alle soglie di contingentamento dei rapporti.
L’articolo 4 dell’accordo territoriale prevede infatti:
- la possibilità di assumere una risorsa aggiuntiva (rispetto a quanto previsto dal Ccnl) per le aziende che hanno fino a 50 dipendenti;
- la soglia complessiva del 38% (di cui il 30% massimo per i rapporti a termine e il 10% massimo per quelli in somministrazione) per le aziende con più di 50 dipendenti.
Sempre in merito ai rapporti a tempo determinato, i contratti che possono essere siglati per ragioni connesse all’evento giubilare debbono collocarsi tra la sottoscrizione dell’accordo (12 dicembre 2024) e il 31 agosto 2026.
Anche nell’accordo territoriale per il comparto Turismo Pubblici esercizi viene previsto un innalzamento, a favore di tutto il personale, delle maggiorazioni previste per il lavoro festivo (che passa dal 20% al 30%) e di quello ordinario domenicale (quello cioè che prevede la prestazione nella giornata della domenica con riposo in altro giorno della settimana, che passa dal 10% al 15%).La vera novità riguarda la possibilità di stipulare rapporti di apprendistato che assomigliano molto a quelli di natura stagionale previsti in via strutturale dal Ccnl.
Viene, infatti, introdotta l’opportunità di instaurare rapporti aventi durata del periodo formativo pari a 12 mesi declinati per particolari mansioni e figure professionali, quali:
- cameriere di ristorante (che prevede il 4° livello quale destinazione finale);
- banconiere e cameriere di bar, tavola calda e self service (che prevede il 5° livello quale destinazione finale);
- comis di cucina, sala, tavola calda, self service e bar (che prevede il 6° livello quale destinazione finale).
Per le suddette figure vengono anche declinate le ore di formazione (60 per le mansioni di cui ai punti 1 e 2, 40 per quella al punto 3) e soprattutto il trattamento retributivo, che, coerentemente con quanto previsto dal Ccnl, è percentualizzato rispetto al livello di destinazione finale e che tendenzialmente è ancorato a quello dei periodi finali del percorso formativo (95% del trattamento retributivo previsto per le mansioni di cui ai punti 1 e 2, 90% per quella di cui al punto 3).
Anche rispetto a questo aspetto è centrale il ruolo dell’ente bilaterale, che sarà chiamato a fornire il proprio parere di conformità a riguardo.
Altri esempi di contrattazione collettiva di secondo livello per la gestione dei picchi di stagionalità
Come anticipato in precedenza, il protocollo di intesa siglato da Confcommercio per la Regione Lazio – in particolare per quanto attiene al comparto Terziario – non costituisce un’estensione del dettato normativo e contrattuale che prevede deleghe in materia di definizione di gestione della stagionalità, quanto a quella del rapporto a tempo determinato. Ciò è desumile anche dal perimetro che le parti stipulanti hanno inteso dare – sempre restando in tema di rapporto a tempo determinato – alle deroghe estensive.
Basti pensare, infatti, all’innalzamento delle soglie di contingentamento rispetto al numero di rapporti a termine, che tradisce nei fatti la concorrenza di detti contratti al raggiungimento dei limiti previsti ad hoc (sebbene più estesi); i rapporti di matrice stagionale non soggiacciono ad alcuna restrizione numerica.
Proprio l’ampia e profonda gamma delle deroghe che sono previste a favore dei rapporti a termine di natura stagionale va maneggiata con cura, specie quando tale definizione (quella di stagionalità) non derivi da fonte normativa (D.P.R. 1525/1963), ma da declinazione contrattuale collettiva (in base alla delega di cui all’articolo 21, comma 2, D.Lgs. 81/2015).
Sul punto è stato assolutamente opportuno l’intervento del Collegato lavoro (L. 203/2024) e, in particolare, dell’articolo 11, che contiene una norma di interpretazione autentica in tema di ruolo definitorio della contrattazione collettiva rispetto alla declinazione del concetto di stagionalità.
Tale intervento si è reso necessario a seguito del restrittivo orientamento della giurisprudenza in merito alla distinzione tra stagionalità in senso stretto e periodi di più intensa attività.
Specie il comparto del Terziario (ma non solo quello) sconta il fatto che la vocazione turistica di gran parte del nostro territorio nazionale necessita di gestire periodi nei quali l’attività è più intensa (e con essa il fabbisogno di personale).
Fatta la dovuta distinzione introduttiva, e l’annessa precisazione in termini di oggetto, può essere utile analizzare alcuni contratti collettivi di secondo livello, calibrati sulle deroghe in tema di stagionalità, al fine di valutare punti in comune e differenze.
Si ribadisce che il protocollo d’intesa previsto nella Regione Lazio non ha valenza stagionale, ma tratta il rapporto a termine in virtù della delega generale offerta dall’articolo 19, comma 1, D.Lgs. 81/2015, ed è da considerarsi sui generis per via del fatto che non si limita a disciplinare uno schema contrattuale specifico, ma offre strumenti organici e complessivi per sopperire a quello che sarà il maggior afflusso nel territorio regionale in generale, e romano in particolare, nel corso del periodo giubilare.
Provando a fare un parallelismo con altri accordi territoriali simili – al netto della difficoltà a reperire contratti completamente sovrapponibili per filosofia complessiva – può essere utile andare a considerare:
- il contratto collettivo regionale per la Regione Toscana dell’aprile 2022;
- il contratto collettivo provinciale per la Provincia di Venezia del maggio 2017.
Entrambi gli accordi muovono dall’esigenza di gestire i picchi di più intensa attività all’interno di un contesto, quello del Terziario appunto, che si caratterizza per:
- l’assenza di una previsione normativa che ancora il concetto di stagionalità a periodi di chiusura predeterminati nel corso dell’anno solare (come, ad esempio, accade per i pubblici esercizi);
- lo svolgimento di attività di vendita che tendenzialmente sono rivolte ai medesimi prodotti, solo con un sensibile incremento in particolari momenti dell’anno.
Come detto, i 2 accordi qui esaminati, rispetto alla particolare disciplina del tempo determinato, sono riferiti al concetto di stagionalità, per cui le deroghe previste rispetto all’impianto generale sono decisamente più ampie e riguardano in particolare:
- assenza di limite temporale massimo riferito ai rapporti a termine;
- assenza di limiti di contingentamento;
- assenza di obbligo di intervalli temporali tra rinnovi;
- assenza dell’obbligo di prevedere delle causali.
Il punto in comune, al netto delle differenze sopra citate in termini di finalità, è dato dalla definizione anche nei 2 accordi sopra citati, di un contesto territoriale e di periodi nel corso dell’anno nei quali si registrano i picchi di più intensa attività e all’interno dei quali è, quindi, possibile stipulare contratti che sono attratti nel concetto di stagionalità per previsione contrattuale collettiva territoriale.
In particolare, nell’accordo collettivo regionale per la Toscana, l’intero territorio regionale viene considerato a vocazione artistico-culturale e vengono declinati differenti periodi nel corso dell’anno dove possono registrarsi incrementi dell’attività.
Impianto sostanzialmente analogo è rintracciabile nell’accordo territoriale per la Provincia di Venezia, dove vengono definiti i Comuni a vocazione artistico-culturale e i periodi dell’anno (in questo caso uguali per l’intero ambito geografico definito) all’interno dei quali le assunzioni vengono considerate rientranti nel concetto di stagionalità.
Ciò che cambia tra gli accordi territoriali per la Regione Toscana e per la Provincia di Venezia qui esaminati, rispetto alla fisionomia del protocollo di intesa per la Regione Lazio, è rintracciabile nella deroga più ampia e profonda rispetto alla disciplina generale del contratto a tempo determinato.
Si segnala che l’articolo è tratto da “Contratti collettivi e tabelle”.