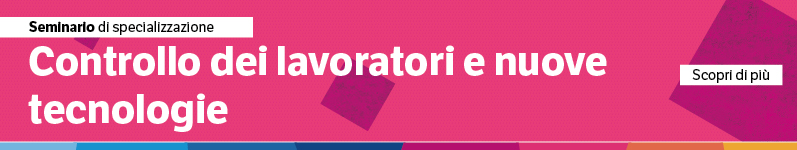Alle radici del “costo del lavoro”: la nozione lavoristica, fiscale e contributiva di “retribuzione”
di Federico Avanzi Scarica in PDF
La riflessione oggetto del presente contributo si pone un obbiettivo molto chiaro ossia, da una parte, tentare di sottrarre alla facile retorica o, potremmo dire, alla narrazione spesso strumentale, il tema del “costo del lavoro” in Italia, cercando di offrire, seppure in sintesi, ma con riferimento a dati oggettivi, un quadro di “contesto” del nostro Paese, dall’altra, ma partendo sempre da evidenze analitiche, offrire una prospettiva differente di questa ricorrente tematica, diciamo pure più giuridica, evidenziando come, ad avviso del sottoscritto, una parte significativa del dibattito sul “costo del lavoro” dovrebbe, più che altro, concentrarsi sulla complessità della nozione di “retribuzione” e sulla struttura della stessa, propria del nostro ordinamento.
Introduzione
L’argomento sempre caldo del “prezzo” del lavoro viene circoscritto, anche e soprattutto in ambito di comunicazione/informazione dei media, al tema del c.d. cuneo fiscale, cioè, come noto, il delta fra la retribuzione percepita, in concreto, dal lavoratore e il correlativo onere finanziario, nel complesso, sostenuto dal datore di lavoro.
Un delta che in questa comune narrazione viene ricondotto e imputato, con accezione sovente negativa, essenzialmente a 2 fattori: al prelievo fiscale Irpef e, soprattutto, agli oneri previdenziali Inps.
Ora, in disparte dalla notoria constatazione circa il ruolo “fondamentale”, in una prospettiva di sostenibilità, attuale e futura, di queste incombenze, anche solo facendo menzione, per esempio, all’impostazione “a ripartizione” del nostro sistema previdenziale/assistenziale e alla sua vitale necessità di attingere alla “fiscalità generale”, mi sembra opportuno contestualizzare, anche in ottica minimamente comparata, questa ricorrente doglianza, che, personalmente, ritengo solo in parte fondata.
Allora, ricorrendo alle rilevazioni di varie autorevoli fonti, istituzionali e non, mi preme mettere all’evidenza che quando discorriamo di “costo del lavoro” in Italia dobbiamo, giocoforza, muovere dalle peculiarità di un contesto dove:
- per l’anno 2021, i redditi dichiarati superiori a 35.000 euro lordi sono solo il 13,94%, mentre quelli sotto i 15.000 euro, sempre lordi, risultano oltre il 40% (Fonte Itinerari Previdenziali);
- sempre con riferimento all’anno 2021 sono state stimate 2,6 milioni unità di lavoro dipendenti equivalenti full–time di “sommerso”, cioè il 15,2% del totale dei dipendenti (Fonte Istat);
- dove, ancora per l’anno 2021, solo il 48,2% dei dipendenti registra una durata del periodo di lavoro retribuito pari a un intero anno (Fonte Istat);
- mentre allargando un po’ l’orizzonte temporale, stiamo parlando di un Paese dove, nel periodo 2008-2017, i lavoratori sottooccupati e part–time involontari sono aumentati, rispettivamente, dell’82% e del 98% (fonte Eurostat);
- e dove, ancora, nel periodo 2000-2022 si è registrata una riduzione delle ore lavorate dai dipendenti del 7,9%, pari a 133 ore l’anno (fonte Istat);
- e dove, avviandomi verso la conclusione di questa breve, e a mio avviso “impietosa” rassegna, secondo recenti studi, inerenti al 2023, sembrerebbe che, con riguardo ai Ccnl più applicati, solo 15 su 154, per le categorie più basse, hanno un Tem (paga base + contingenza) più alto di 9 euro (fonte: Damiano, Rotondi).
Tutti dati, questi, che tornano e possono essere compendiati in 2 rilevazioni spesso richiamate nelle discussioni in tema di salario minimo e costo del lavoro:
- una, di fonte Ocse, nella quale si dà conto che nel trentennio 1990-2020, tra 35 Paesi censiti, l’Italia è l’unico Paese con perdita del potere d’acquisto del -2,9%;
- un’altra di fonte interna e precisamente Inapp, dove si evidenzia che nel periodo 2000-2022, la produttività d’impresa è cresciuta del 5,6%, mentre le retribuzioni solo dell’1,9%.
Di contro, basta accedere alle statistiche di Eurostat per avere cognizione del fatto che il costo del lavoro italiano, inteso nella “semplificata” accezione di cui facevo cenno prima, se confrontato agli altri Paesi membri, non si colloca certo ai vertici della “classifica”, risultando alle spalle di Francia, Germania e Austria, oltreché ai Paesi del Nord Europa.
Tutto ciò considerato, dunque, a mio avviso, se dovessimo dare una priorità di argomenti da trattare con urgenza, direi che i dati sopra menzionati dovrebbero indurre a concentrare le energie e gli sforzi, in prima battuta, sulla questione “salariale”, piuttosto che sugli “oneri” fiscale e contributivi, gravanti, sì, sull’impresa, ma necessari alla sostenibilità del già “pericolante” welfare state, almeno così come lo conosciamo oggi.
E tuttavia, in una prospettiva, come si diceva, più giuridica e consona all’odierno contesto, sicuramente abbiamo anche un modo per considerare unitamente questi 2 aspetti, che taluno potrebbe definire anche 2 facce della stessa medaglia, ossia indagare e approfondire la struttura di questo “costo del lavoro”.
Anche qui, sia attingendo da fonti internazionali, sia da rilevazioni interne[1], il ritorno che abbiamo è la tangibilità del fatto che il grosso della componente, oltre il 70% di questo valore, è rappresentato da retribuzione lorda, declinata in tutte le sue varie accezioni e che nel documento dell’Istituto di statistica vengono suddivise in “importi ricorrenti”, “non ricorrenti”, “remunerazione per ore non lavorate” e, da ultimo, anche “contributi sociali”, dove viene collocato il Tfr; categorie che, comunque, dal punto di vista giuslavoristico, possono essere riassorbite nei più familiari concetti di retribuzione “corrente”, “differita” e “indiretta”.
Mentre, sull’altro versante, la contribuzione che alimenta il sistema previdenziale o la pressione fiscale sul reddito da lavoro dipendente, sempre in ottica comparata e anche guardando al contenuto dell’ultimo Rapporto annuale Inps[2], non sembra certo potersi tacciare di “irragionevolezza” o di aver raggiunto qualche ingiustificato primato nell’ambito dell’Unione.
Frammentazione della retribuzione e prospettive definitorie
Cosicché, a me pare, che se di costo del lavoro vogliamo discutere, anche de jure condendo, 2 sono le direttrici da approfondire, fra loro connesse e foriere di complessità nonché incertezza, per aziende e operatori del diritto, nella gestione del trattamento economico del lavoratore subordinato:
- una prima, nella prospettiva “interna” al rapporto, tra datore e lavoratore, derivante dall’assenza di una nozione “onnicomprensiva” di retribuzione[3], a favore, all’opposto, di una consistente “frammentazione” della stessa;
- una seconda, da un’angolazione “esterna”, inerente alle notevoli implicazioni derivanti dalle similari, ma non coincidenti, definizioni di retribuzione dei cogenti e contestuali rapporti che sorgono con l’obbligazione lavorativa.
Sul primo tema, mi limito a citare le questioni, se non nuove, potremmo dire rinnovate, direttamente connesse allo “stemperato” criterio di corrispettività che caratterizza la relazione subordinata ossia, per andare nel concreto, la necessità di quantificare, senza possibilità di parametri oggettivi e predeterminabili, un nutritissimo novero di istituti non collegati all’effettiva prestazione del dipendente.
Qui, anche la più recente giurisprudenza mette in risalto forti criticità, che sfociano in frequente contenzioso, legato all’esatto conteggio del valore patrimoniale da riconoscere a emolumenti quali la retribuzione utile per il calcolo del Tfr (articolo 2120, cod. civ.), del preavviso (articolo 2121, cod. civ.), delle festività (articolo 5, L. 260/1949), delle ferie (articolo 7, Direttiva 2003/88/CE).
Come noto, tutte queste dispute giurisprudenziali vertono sugli elementi per così dire “variabili”, erogati in esecuzione delle mansioni assegnate, da computare o non computare, nel calcolo: ci si riferisce a straordinari, premi, indennità di trasferta, benefit in natura; tanto più è complesso il trattamento economico previsto per la prestazione effettiva, tanto sarà più esasperata la contesa, fra le parti, sul ricalcolo degli emolumenti c.d. differiti.
Questo, con uno stato dell’arte giurisprudenziale dove alla magistratura del lavoro, specialmente di legittimità, non è consentito andare oltre l’affermazione di obblighi di principio, solo talvolta traslati in qualche flebile indicazione operativa: come in tema di ferie, dove la Cassazione, come noto, facendo leva sul diritto dell’Unione Europea, da una parte, si è attestata, con rigore, sulla pur giusta statuizione “di riconoscere al lavoratore … in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione Europea [e] in misura tale da garantire al … medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l’attività lavorativa”, dall’altra, limitandosi, però, a suggerire l’utilizzo di “meccanismi che tenga[no] conto, per esempio, del riconoscimento di una media delle ore di lavoro effettivo ai fini del computo” (Cassazione n. 20216/2022).
Considerando poi che, in altre contingenze prettamente contrattuali, come, ad esempio, mensilità aggiuntive e permessi, ci si mette pure l’equivoca – talvolta consapevolmente – autonomia collettiva a soffiare sul fuoco del contenzioso, si veda, per tutte, la “permanente” incertezza inerente al quantum di detta retribuzione nel Ccnl Metalmeccanica industria e di molti altri contratti collettivi (Cassazione n. 28937/2018), di quale “costo del lavoro” dovremmo discutere, se non, in primis e con intenti almeno parzialmente solutori, di quello rappresentato dalla “giungla retributiva”, rievocando illustre dottrina, del lavoratore subordinato e di “angoli ciechi” del diritto lavoristico, dove è sostanzialmente impossibile una sua certa definizione e/o quantificazione?
Sul secondo e, come dicevo, interconnesso aspetto della vicenda, mi limiterei a osservare le numerose questioni sorgenti dalla tripartizione, a effetti sostanziali, della nozione di retribuzione: lavoristica, fiscale e contributiva; suddivisione che, peraltro, non può che corroborare l’autorevole pensiero dottrinale secondo cui esisterebbero una “molteplicità di definizioni …, che soddisfano, volta a volta, finalità diverse”[4].
In questo senso mi riferisco al fatto che, nonostante ci si sia adoperati, per via legislativa, a tentativi di ricomposizione o, per meglio dire, “armonizzazione” del quadro (articolo 6, D.Lgs. 314/1997), siamo ben distanti da un principio di “unificazione” del trattamento economico, avendo, a ordinamento vigente, segmenti di legislazione disciplinanti gli autonomi rapporti che, ex lege, si instaurano a riverbero dell’inizio della prestazione lavorativa: quello civile-lavoristico, fra datore di lavoro e lavoratore; quello contributivo, fra datore di lavoro ed ente di previdenza (Inps; si veda infra), dipendente dalla precisa e inderogabile disposizione normativa sull’obbligo inerente alle assicurazioni sociali[5]; quello fiscale, fra lavoratore e Amministrazione finanziaria (Agenzia delle entrate; articoli 49 ss., Tuir), fondato sulla “prestazione tributaria”, la quale si identifica “nella presenza di una disciplina legale, finalizzata in via prevalente a provocare una decurtazione patrimoniale del soggetto passivo, svincolata da ogni modificazione del rapporto sinallagmatico”[6].
E la presenza di questo intreccio normativo non del tutto compiuto nelle sue “connessioni”, rappresenta, naturalmente, fonte di incertezza nei rapporti e di conseguente contenzioso.
Basti pensare ai casi sempre più ricorrenti di pronunce, anche di legittimità, dove la Corte di Cassazione si vede costretta a “richiamare” i giudici della fase di merito ovvero le stesse parti in causa, le quali, erroneamente, al fine di dirimere una controversia sulla sussunzione nella nozione di “retribuzione” di un certo trattamento economico a fini lavoristici, magari per sottrarlo ovvero farlo rientrare sotto la protezione del principio di “irriducibilità” (articolo 2103, cod. civ.), avevano maldestramente fatto leva sul dato normativo regolante il rapporto fiscale o quelle contributivo.
In dette circostanze, il Supremo Collegio non ha mancato di sollecitare, in ragione dell’anzidetta autonomia dei rapporti, che dalla qualificazione fiscale ovvero contributiva delle somme non possono trarsi indicazioni destinate a incidere anche sulla configurazione delle stesse nell’ambito del rapporto di lavoro (Cassazione n. 1289/2023 e Cassazione n. 13185/2022), sancendo così un’incidenza che, in nessun caso, può trascendere la fattispecie regolata.
Ma, ancora, si rifletta sul nutritissimo contenzioso previdenziale derivante non solo dalle aporie discendenti dall’elencazione tassativa delle esclusioni dalla base imponibile ex articolo 12, comma 4, L. 153/1969, e dalle conseguenti difficoltà di inquadrare specifici istituti come, a titolo esemplificativo, le somme erogate in occasione della cessazione del rapporto[7], il risarcimento del danno[8] o i patti “di non concorrenza”[9], ma anche e soprattutto dipendente dal principio di retribuzione c.d. virtuale, prescritto, in primo luogo, dall’articolo 1, D.L. 338/1989. Un criterio, questo, che porta, come noto, alla divaricazione fra retribuzione “erogata” o, comunque, dal punto di vista “obbligatorio”, rilevante fra datore di lavoro e lavoratore e quella, in ogni evenienza, pertinente ai fini contributivi dove si hanno ben quattro concomitanti norme di disciplina:
- l’articolo 12, L. 153/1969, che, come detto, determina le voci da sottoporre a contribuzione;
- l’articolo 1, D.L. 338/1989, che determina, a proposito di salario minimo, unitamente alla retribuzione minima giornaliera di cui all’articolo 7, D.L. 463/1983, l’imponibile su cui applicare la pertinente aliquota di finanziamento;
- dulcis in fundo, l’articolo 3, D.L. 318/1996, il quale impone il calcolo della stessa, rispettando, rigidamente, clausole, tempi e modi previsti dalla contrattazione collettiva; si veda a tal riguardo il contenzioso sui limiti contrattuali di contingentamento al lavoro part–time e, finanche, all’esercizio delle clausole elastiche (Cassazione n. 29718/2022).
Da questo derivano estremizzazioni di concetto, con avvallo nomofilattico, per le quali, ai fini contributivi, non solo diviene priva di rilievo la mancata erogazione della retribuzione o, altresì, la sospensione, concordata della prestazione, ma, finanche, “la forza maggiore non imputabile al datore di lavoro” (Cassazione n. 18954/2023).
Del pari, analoghe questioni permeano anche il rapporto tributario, dove, per dirne una, è risaputa tutta l’incertezza legata alla gestione delle somme erogate a titolo di anticipazione e/o rimborso delle spese sostenute dal lavoratore (da ultimo, interpello n. 41/E/2023).
Infatti, in una permanente “tensione” fra prassi dell’Amministrazione finanziaria e giurisprudenza, non sembrano ancora ben delineati i confini delle eccezioni al principio di “onnicomprensività” fiscale, il quale si attesta, ancora oggi, per accertare la natura restitutoria delle erogazioni, su espressioni di principio come la verifica dell’interesse esclusivo del datore di lavoro (risoluzione n. 357/E/2003) e l’individuazione dei valori sulla base di elementi oggettivi e documentalmente accertabili (risoluzione n. 74/E/2017).
Problematiche che riguardano, evidentemente, anche la nozione di retribuzione lavoristica, posto che, da questa, come detto poc’anzi, dipendono “effetti” fra le parti tutt’altro che privi di significato, come, su tutti, la questione dell’irriducibilità dell’emolumento in origine pattuito o la sua incidenza nella quantificazione di altri istituti, come detto in precedenza.
Ma, anche in questo caso, la giurisprudenza sembra costretta a muoversi per “approssimazione”, tentando di applicare, al caso concreto, il criterio di corrispettività, cioè ricercando il carattere retributivo a tutte quelle corresponsioni finalizzate all’arricchimento del prestatore in correlazione all’esecuzione, con professionalità o disagio, delle mansioni assegnate[10], unitamente al parametro discretivo, già citato in precedenza, dell’interesse soggettivo[11].
A tal proposito, segnalo un crescente contezioso inerente alla natura da attribuire a benefit o servizi che potremmo dire di welfare riconosciuti per il tramite della contrattazione collettiva[12].
Conclusioni
In definitiva, volendo trarre qualche conclusivo spunto, a me pare che, nel solco di quanto detto sin qui, discutere di “costo del lavoro” limitandosi a denunciare, fuori da ogni benché minima contestualizzazione, la gravosità del cuneo fiscale italiano, finisca col divenire una fuorviante banalizzazione dei concetti, oltreché risultare priva di qualsivoglia utilità.
Piuttosto, sono convinto che vi siano o meglio permangano[13] doverosi spazi di discussione sulla complessità della nozione di retribuzione propria del nostro ordinamento, la quale rappresenta, forse, il più vero, severo e intrinseco dei “costi” da sostenere, dovendo, pertanto, indagare eventuali margini d’iniziativa, sia politica sia sindacale, per una sostenibile razionalizzazione della stessa o, comunque, per una parziale risoluzione delle numerose criticità innanzi citate.
[1] Si veda il report Istat del 14 dicembre 2022.
[2] XXII Rapporto annuale, pag. 198 ss..
[3] Cassazione, SS.UU. n. 1081/1984.
[4] O. Mazzotta, “Diritto del lavoro”, 2013, Giuffrè.
[5] Così, Corte Costituzionale, n. 163/1983.
[6] Corte Costituzionale, n. 178/2015.
[7] Tribunale di Ivrea, n. 31/2008.
[8] Inps, circolare n. 6/2014.
[9] Cassazione n. 16489/2009.
[10] Cassazione n. 16636/2012.
[11] Si vedano le esemplificazioni contenute in Cassazione n. 3928/2007.
[12] Ex multis, Cassazione n. 25504/2023; Cassazione n. 28993/2023.
[13] Cnel, parere 24 gennaio 1978, n. 163/112.
Si segnala che l’articolo è tratto da “Il giurista del lavoro”